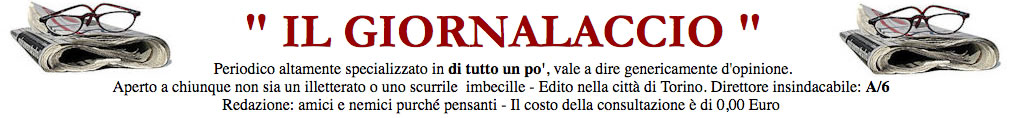Radice d’ombra – Italic Pequod, Ancona, 2016
Radice d’ombra – Italic Pequod, Ancona, 2016
Roberta Ioli vive a Cesena, insegna filosofia e storia ed è studiosa del pensiero antico. È autrice di numerosi contributi sul mondo classico, su scetticismo greco e sofistica, e si è occupata soprattutto del valore della parola nel sofista Gorgia e della relazione tra inganno, arte e passioni tragiche. Tra i suoi lavori più recenti si ricordano Teocrito. L’Incantatrice e altri idilli (Ladolfi 2012), Gorgia. Testimonianze e frammenti (Carocci 2013). Per le Edizioni della Stoà ha pubblicato “Vocem devorat dolor. Ecuba e la voce del lamento”, una riflessione sull’intreccio tra corpo, voce e tragedia, nata dalla collaborazione con Chiara Guidi. Le sue raccolte poetiche sono “L’atteso altrove” (Italic/Pequod 2014) e ora questo “Radice d’ombra”.
“Radice d’ombra”, il titolo di questa seconda raccolta poetica di Roberta Ioli, è anche l’ultima parola del libro, l’ultimo verso che chiude l’ultima poesia e che coagula il senso di un lungo percorso appunto in questa immagine: «Per riposare la tua stanchezza / nascondi forse in questo tempo / l’infelice regno, e più a fondo scavi / d’ogni cosa creata / la radice d’ombra». Ma il lettore che ha attraversato l’intera silloge coglie in questa espressione l’estrema metamorfosi di una ferita originaria, di un’ombra da cui tutto il discorso è partito, e che appare per la prima volta alla fine del testo proemiale […]. La «radice» è un’immagine plurisensa, di cui si potrà ora cogliere il senso negativo, di antica condanna ombrosa che di sé tinge «ogni cosa creata», negando o almeno oscurando la luce e la gioia; ora invece seguirne lo sviluppo, la crescita, poiché la radice, per sua natura «tenace», non intende rinunciare al proprio divenire, né può più «ridiscendere», e sarà dunque costretta a cimentarsi in una risalita, difficoltosa, improbabile eppure inevitabile. Così scrive fabio Pusterla nella sua prefazione. E mi pare colga un aspetto essenziale di questo libro sospeso, scuro, sofferto.
Certamente “il negato amore” dell’innocenza, dell’infanzia perduta sono un polo importante di questa raccolta. Non c’è nostalgia, c’è dolore per il distacco e malgrado il tentativo di universalizzare (si veda la poesia El Desdichado – Per Nerval) col suo incipit “noi clandestini” la questione resta una “questione privata”, personale. “Impossibile tornare al cerchio/degli affetti…. Quella nuova fragile pelle/è l’unica terra che possiamo abitare/”.
Insomma è il contorno fragile e incerto del corpo, del sé che ci resta a disposizione perché “non siamo mai/fino in fondo/ l’ospite che si sa atteso”. Ed è questa precarietà, questo senso di esclusione che domina la trama. E ci si ritrova a curare le “ferite dell’insonnia”, stato fisico e dell’anima, a contemplare le onde del mare mentre “noi siamo a terra invece/relitti sopravvissuti all’onda/, a riflettere su come “ci credevamo immortali/nella luce che accoglieva il nostro riso”. Restiamo così in disparte, ai margini prima che e di nuovo ci colga l’ansia di cercare “l’esatta lingua del dolore/libero dai sigilli di famiglia”.
La lingua di Roberta Ioli è densa, spugnosa, carica di ombre eppure pulita. Una lingua fatta di non detti, di allusioni eppure dispiegata con limpida chiarezza. Questo il paradosso del suo scrivere che richiede attenzione e concentrazione al lettore. C’è un senso di fatica lucida che apre a domande complesse e irrisolte: “Mi chiedo se sia questo/il destino che ho scelto – osservare dai bordi-/ o non sia il caso ad avermi dimenticato/tra gli scarti del tempo/”.
Questo tema del dentro e del fuori, dell’essere all’interno di un mondo o di starne fuori dimenticato ritorna spesso in questa silloge: è come se la geografia esistenziale, la ricerca di una collocazione (perse le certezze dell’infanzia) sia la cosa che conta per l’individuo. E ancora ritorna nei versi la carezza di un passato perduto “Non chiedevamo niente/solo quel cielo di storni impazziti/quel sapore di ferro sul binario/staccato da ogni cosa attorno a noi/nell’attesa che compie e non consuma/”.
Non si tratta di mitizzare il passato, ma certamente è nel ricordo, nell’attimo felice perduto che si racchiude una speranza di felicità. Fare i conti con la colpa, forse anche con quella di non accettare i propri limiti, il proprio essere “legno storto”, è qualcosa che ci segna, come in un destino collettivo che ci riconnette col mondo della classicità. Che l’autrice ben conosce per ragioni professionali e di formazione. Ma c’è una via d’uscita: “La bellezza della nostra imprecisione” e siamo qui, vivi, “nel furore degli abbracci/ nel toccare insensato che ci incanta”. Uscire dalle maschere, anche da quelle del dolore, forse, da quelle del lamento. Perché altrove “parla la tenerezza per le creature stanche”, perché talvolta vediamo che “il cielo è un quaderno pulito”, perché si può dire “mi fido delle stelle”.
La radice d’ombra che apre e chiude il libro è forse il sigillo di una scelta stilistica e strutturale, utile a segnare la natura circolare di questa poesia, che tuttavia, di tanto in tanto, esce dalla sua tana buia e guarda da un’altra parte.
Stefano Vitale