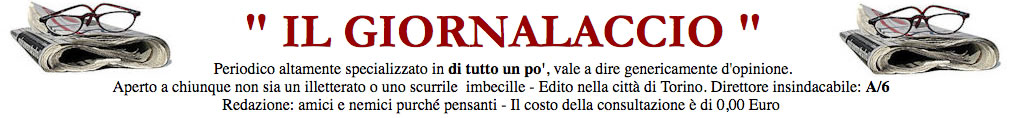Il mondo è scosso, una volta di più, da atti violenti di terrorismo, momenti tragici di una lunga infinita guerra.
Il mondo è scosso, una volta di più, da atti violenti di terrorismo, momenti tragici di una lunga infinita guerra.
Il 1 luglio a Dacca, in Bangladesh, il penultimo atto, dico penultimo perché intanto altre stragi stanno rendendo sempre più invivibile questi nostri tempi. Qui sono stati uccisi 9 italiani, 7 giapponesi, 2 bengalesi, un americano, una ragazza indiana. I terroristi hanno tenuto in ostaggio dentro ad un ristorante vicino l’ambasciata italiana, 35 persone. Le hanno torturate e uccise a colpi di coltello e machete: tutto è durato 10 ore.
I terroristi si sono dichiarati dell’Isis e abbiamo poi scoperto che facevano parte della ricca borghesia locale. La morte e la violenza come gioco assurdo. Dopo la terribile notte all’Holey Artisan Bakery di Dacca, emergono i dettagli e le storie degli sfortunati protagonisti, vittime del furore jihadista. Sono tante allora le storie che attraversano questa orrenda vicenda e la pena maggiore è per le vittime innocenti. Qui voglio soffermarmi sulla storia di Faraaz Hossein: è una storia di coraggio.
Lui era mussulmano, come i terroristi, e aveva la possibilità di salvarsi, ma ha scelto di non abbandonare le amiche. Ed è morto con loro. Faaraz conosceva i versetti del corano che avrebbe potuto recitare per salvarsi in questa assurda sottospecie di roulette russa di cui di beano gli assassini. Bengalese, vent’anni, Faraaz stava cenando al ristorante assaltato dai terroristi insieme con due ragazze, un’americana compagna di college negli Stati Uniti, in Georgia, ed un’indiana che studiava in California. Quando il commando ha fatto irruzione, le vittime prescelte sono state selezionate in base alla propria fede religiosa ed alla conoscenza del Corano.
Faraaz, secondo i testimoni, è stato graziato perché musulmano e gli è stato offerto di lasciare il locale, insieme alle altre donne che indossavano il velo. Quando però le sue amiche sono state bloccate, perché indossavano abiti occidentali, lui ha fatto marcia indietro, decidendo di restare con loro. E diverse ore dopo il blitz che ha neutralizzato i suoi carcerieri, è stato trovato morto con altri 19 ostaggi.
Faraaz era uno studente della Emory University, ricco college privato americano. Un collega, Rifat Mursalin, lo ricorda come pieno di talento e con una propensione per gli altri, dimostrata attraverso il volontariato in diversi progetti scolastici. La sua compagna di sventura si chiamava Abinta Kabir. Nata a Miami, ma di origini bengalesi, era rientrata a Dacca per far visita ai familiari. Con Faraaz erano amici d’infanzia e al college facevano parte del comitato studentesco. La sera del ristorante erano insieme a Tarishi Jain, 18enne studentessa indiana a Berkeley il cui padre si era trasferito diversi anni prima in Bangladesh per affari. Anche lei è stata protetta da Faraaz fino alla fine, anche se inutilmente.
A casa di Faraaz, nel quartiere di Gulshan, non lontano dal luogo della strage, c’era poi stata una processione di parenti e amici per le condoglianze. «Darei tutto per avere mio figlio indietro, ma non avrebbe mai perdonato se stesso se avesse lasciato le sue amiche là dentro», diceva la madre. «Le ferite sul suo corpo mostrano che ha lottato prima di morire, ha preso la lama tra le mani, ha tentato di difendere le sue amiche», dice al Corriere il fratello maggiore, Zaraif.
Non era povero, era della stessa classe dei suoi carnefici. Non è una storia di povertà che è in lotta contro la ricchezza. E’ una grande immensa tragedia dell’idiozia. La sua famiglia possiede Transcom, una delle più grosse e vecchie aziende del Bangladesh, con interessi dai giornali alle bibite all’elettronica. «Io e Faraaz sognavamo di dirigere insieme l’azienda di famiglia», spiega ancora Zaraif, che è solo un anno più grande. La sua voce è ferma: vuole parlare di Faraaz. Vuole che sia ricordato per la sua bravura: «Era tra il 10% dei migliori studenti di Emory. Aveva fatto una internship in India presso PepsiCo e aveva strabiliato tutti. Era destinato a grandi cose». Vuole che sia ricordato per il suo coraggio: «La sua morte rivela ciò che era. Ha resistito ai terroristi. Ha sempre avuto questa forza, sin da piccolo».
Dopo aver cenato con la famiglia, alle 8.30, Faraaz era andato a prendere un caffé all’Holey. Voleva vedere Abinta e Tarishi, studentesse di Emory e di Berkeley, prima di partire con la famiglia per le vacanze in Malaysia. Loro sono arrivate alle 8.40. Aspettavano un quarto amico, Miraaj, che è arrivato alle 8.50 ma sentendo gli spari è corso via. Miraaj ha creato una chat per tentare di raggiungerli: «Vedevamo su Facebook che Faraaz leggeva i messaggi, ma non ha mai risposto».
In Italia si parla giustamente di lottare contro il femminicidio, di sensibilizzare i ragazzi ad una cultura del rispetto e della parità. Le donne non sono oggetti e gli uomini devono poter far parte di questi progetto di costruzione di una nuova visione dei rapporti tra uomini e donne. Faaraz è un esempio vivo, è il caso di dirlo, anche di questa battaglia di cultura. Che deve investire, se mai ci riuscirà, anche l’Islam, da troppo tempo chiuso in una visione della donna, e non solo, come essere senza diritti, inferiore.
Certamente si tratta anche di una storia di amicizia e di amore, e già di per sé basterebbe. Ma non si tratta solo di esaltare lo spirito epico di sacrificio di chi avrebbe potuto salvarsi egoisticamente, ma che ha preferito invece restare legato ad un comune destino, quello delle persone che in quel momento amava ed erano con lui. Non si tratta solo di una forma di ribellione ad un assurdo gioco al massacro fondato sul cinico spartiacque della conoscenza di un versetto coranico. Si tratta di tutte queste cose insieme.
Qui siamo di fronte ad un martire della civiltà e dell’umanità che urla la necessità di superare le diseguaglianze, le discriminazioni, le idiote differenze religiose, di censo per affermare il valore profondo di un’appartenenza comune. Che tiene fuori gli assassini e i torturati di ogni tempo ed epoca, che respinge la violenza gratuita o motivata che sia. Naturalmente Faaraz era giovane: poteva e doveva avere il diritto di vivere, ma è scattato qualcosa di insondabile e inspiegabile che l’ha trattenuto. Forse è stato il pensiero di perdere, fuggendo, la propria dignità; forse ha pensato che non avrebbe potuto vivere nel rimorso-rimpianto di perdere le proprie amiche, due donne. Che come si sa, nella cultura musulmana occupano un posto molto in basso nella scala sociale ed etica.
Forse la frequentazione della “cultura occidentale”, quella dei diritti e dell’uguaglianza universale lo avevano “contaminato”. Non ha ottenuto niente, non poteva salvarle: ha preferito che un destino terribile e cruento gli andasse incontro e lo schiacciasse, così senza una vera ragione.
Chissà se da questa storia impareremo qualcosa di nuovo, di bello e di grande?
Stefano Vitale