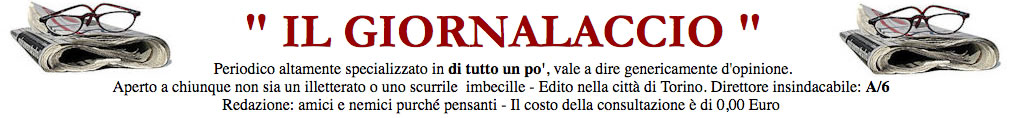Una riflessione in margine al saggio di Giovanni Garbini ‘Dio della terra, Dio del cielo’
Il filologo non cerca verità. La verità la cerca il filosofo, la predica il teologo, la declama il politico, la canta il poeta quando innamorato o ubriaco: che è poi la stessa cosa. Il filologo cerca solo i processi di mutamento linguistico: come le parole si trasformino, mutano di accenti tonici, le lingue si frammentino e diventino altre lingue. In questa ricerca di necessità tratto privilegiato è la registrazione scritta della parola in ogni sua forma: dall’iscrizione funeraria alle stele rievocative, fino al testo letterario.
Accade spesso al filologo, mentre studia i mutamenti linguistici di imbattersi in narrazioni inventate dal potere: politico, religioso, economico, racconti che di fatto servono strumentalmente ai disegni di potenza. Per il filologo sono incontri casuali, ma che possono assumere grande rilevanza per vasti gruppi umani, come esemplarmente illustra il caso della falsa donazione di Costantino, che legittimava la pretesa del papato di governare tutta l’Italia centrale, per il potere trasmessogli dall’imperatore Costantino, che aveva trasferito la potestà politica imperiale su quelle regioni dall’impero alla chiesa.
Il Valla, studioso dell’evoluzione della lingua latina, esaminando il documento in questione, – già contestato da Dante che sostenne non essere in potestà del singolo imperatore alienare parti dell’impero – stabilì che la lingua latina nella quale era redatta la sedicente ‘Donazione’ era in un latino barbarico, che non poteva essere quello dell’evo di Costantino, denunciandone la falsità, con grandi effetti in ambito politico e religioso: tanto lo stato laico che la riforma protestante devono molto alla scoperta del Valla, ma che non era partito in traccia di un documento falsificato. Semplicemente lo trovò, studiando l’evoluzione testuale del latino.
Analogo è il caso del saggio di Carlo Pascal, filologo classico principe tra ‘800 e ‘900. Fondamentali suoi contributi sull’evoluzione del poesia metrica tanto greca che romana. Agli inizi del secolo, lavorando su materiali dell’evo dei cesari, Carlo Pascal pubblicò un breve saggio ‘L’incendio di Roma e i primi cristiani’ (di recente riproposto da Mimesis) che suscitò allora vastissima eco, in quanto scagionava Nerone e individuava nel circolo dei millenaristi cristiani, attivi nella corte neroniana, gli incendiari, che avevano attuato il piano criminale ad affrettare la venuta del giudizio di Dio.
Tanto Pascal che Valla hanno trovato e rivelato il rimosso, che spesso involontariamente trasforma il lavoro del filologo in smascheramento delle falsificazioni del narrato religioso e/o politico, costruito per proiettare una immagine del reale in funzione della difesa di un gruppo di potere, per il quale costruire quella che poi apparirà una clamorosa falsificazione è sempre una intrinseca, perfin virtuosa necessità.
In questa logica del contributo trovato e non cercato: in ogni caso non l’oggetto originario della ricerca e della riflessione, si inscrive il formidabile contributo a una aggiornata riflessione sull’origine del cristianesimo del filologo semita Giovanni Garbini ‘Dio della terra dio del cielo’ (Paideia editrice, 2011, pp 350, € 35).
Il libro, frutto terminale d’una lunga vita di ricerca d’un insigne studioso, ricostruisce l’evoluzione della religiosità tra i popoli semiti dalla preistoria fino alla nascita dell’islam, che avrebbe posto fine al lungo evo di frammentazione tanto religiosa che politica e linguistica del vasto ceppo di popolazioni semite.
Il tratto che contraddistingue la religiosità semita, molto semplificando, è per Garbini la natura ctonia infera delle divinità maschili, mentre l’aspetto femminile, identificato nell’elemento lunare, rappresenta l’aspetto celeste, in un dislocarsi opposto e simmetrico rispetto alla religiosità indoeuropea, per la quale l’elemento maschile è l’elemento celeste.
Ricostruendo, su frammenti epigrafici spesso minimi la spiritualità di un lungo evo, entro questo percorso, Garbini affronta come un capitolo della sua ricerca, il tema del sorgere e definirsi del monotesmo ebraico e della sua eresia cristiana, poi destinata a diventare prima la religione dell’impero romano e poi dell’occidente.
Di tutto questo grandioso divenire, come della tenace sopravvivenza del culto ebraico di Yhavè, il filologo non si cura, nella sua sfera di ricerca soltanto, si fa per dire, cogliere il processo di trasformazione del politeismo palestinese d’ambito ebraico in monoteismo.
All’origine, inizi, primo millennio a.C., Yhavè è il dio ctonio importato dalle tribù ebree, che lo veneravano in Gerusalemme, ritenendo sotto la roccia dove poi fu edificato il tempio, il luogo di comunicazione con questa entità infera, che aveva in loco sostituito un precedente dio: la prima costruzione del tempio risale ai filistei, che gli ebrei vincitori espulsero da Gerusalemme. Questa la dinamica storica, mentre la ricerca filologica e archeologica conferma un Yhavè dio infero, la cui teologia i sacerdoti della tribù amorrea insediatasi in di Palestina e all’origine del popolo ebraico, mutuano in gran parte dai più avanzati semiti della costa del Libano: i fenici. Un dio con una dea come compagna e altre divinità minori.
Soltanto a contatto con gli dèi mesopotamici durante l’esilio babilonese, e poi della religione imperiale persiana, Yhavè si trasforma per gradi da dio infero in un dio celeste, ma ancora sotto il regno persiano di Dario nel tempio di Gerusalemme si adora con il dio Yhavè la sua sposa Ashera, mentre permane il rito del sacrificio del primogenito, come pratica normale corrente; rituale tragico tipico di tutta la religiosità semita, che perdurerà ancora sotto l’impero romano, come documentano gli editti contro tale pratica di governatori romani della provincia semitizzata d’Africa.
Nel sacrificio del primogenito va individuata la surrogazione del sacrificio del re, all’origine la pratica del sacrificio ristretta alle famiglie reali. Quanto questo rituale fosse al centro della spiritualità semita lo descrive un episodio storico sul quale la riflessione di Garbini si sofferma.
Tornando, dopo il crollo dell’impero babilonese da Babilonia, gli ebrei deportati trovano i loro territori occupati da popolazioni semite d’area del sud: provenienti dalla zona del Sinai, che entrano in conflitto con gli ebrei tonati da Babilonia soprattutto intorno al controllo del centro cultuale del tempio in Gerusalemme. Il gruppo che definiamo sinaita per semplificare, uccide il re Zorobabele tornato dalla cattività babilonese, in una congiura organizzata dal gran sacerdote, che di fatto diventa re, ma non osa investirsi in linea di diritto, in quanto il nuovo re è il persiano Dario. Zorobadele viene rimosso come figura storica, ma ascende nel culto popolare a grande ostia sacrificale, che protegge e veglia sul paese. La struttura religiosa arcaica semita, fondata sul rito sacrificale, attraverso l’apoteosi del re assassinato rivela il permanere conservativo della struttura religiosa arcaica infera, anche se il Yhavè del tempio è intanto asceso a dio celeste, mentre nel suo tempio in Gerusalemme si celebrano ancora, in evo periano, anche i riti della sua paredra Ashera.
In questo quadro, nell’ambito del tempio, il sacerdozio vive una forte tensione a contatto con la teologia dualista persiana e sotto la pressione del profetismo, entro una situazione politica eccezionale: gli ebrei non hanno più un re e di fatto tutta la vita sociale, confiscato lo spazio della politica dai persiani, cade sotto il controllo della classe sacerdotale, dove sopravvivono, trasformate, le tensioni tra il gruppo tornato dall’esilio babilonese e il gruppo di origine sinaita meridionale. Con l’allentarsi del suo potere e l’avviarsi al tramonto dell’impero persiano, mentre il gran sacerdote del tempio di Gerusaleme assume sempre più tratti regali, si sviluppa una resistenza a questa ascesa del gran sacerdote alla regalità, facendo appello a una identità crescentemente esclusiva tra il dio del tempio e il popolo d’area gerusalemmita, che l’elaborazione teologica cui aderisce una forte corrente sacerdotale identifica con il popolo storicamente trascelto dal dio: nasce la dottrina del popolo eletto e di Israele come la sposa di Yhavè; da dove poi la metafora cristiana della chiesa cattolica come ‘sponsa Christi’.
Questa elaborazione teologica nella direzione d’un rigoroso monoteismo riceve la spinta decisiva da un capitale fatto storico esterno: l’irruzione della colonizzazione greca, un cui effetto è la scoperta da parte del ceto colto del tempio di Gerusalemme della filosofia greca.
Dalla filosofia greca il sacerdozio ebraico più attento e speculativamente aperto deriva l’elemento dogmatico decisivo per l fondazione e legittimazione di una rigorosa teologia monoteista.
Il nuovo Yhavè, il dio del patto, assume la forma tratta da Aristotele: la visione di Dio come primo motore immobile, entro una complessa elaborazione etica derivata dalla filosofia stoica, mentre dal platonismo deriva una nuova interpretazione dell’amore come potente forza del sacro, che trova, in ambito ebraico, la sua massima espressione nel ‘Cantico dei cantici’.
Parallelamente di derivazione epicurea è il pensiero che sottende la redazione dell’Ecclesiaste, con il suo grido: tutto è vanità.
Questa penetrazione profonda della filosofia greca potrebbe travolgere il senso di identità nazionale degli ebrei gerusalemmiti. Contro questa minaccia di dissoluzione della propria identità culturale, il clero ebraico si arrocca nel principio di identità interna, e differenziazione dall’esterno, intorno al culto di un rigoroso monoteismo yhavetico, a dar forma al quale inizia la stesura, in età maccabea, fine IV secolo, di una integrale scrittura della storia di una Israele su un fondale storico del tutto inventato, il cui tratto emblematico il mito mosaico, ad attestare una origine meridionale egiziana di un popolo le cui origini storiche vanno invece ricercate nella zona tra Siria e Palestina intorno alla fine del secondo millennio a. C.
In questi clima di invenzione della tradizione, come momento di questa invenzione della tradizione, prende forma anche la predicazione del profeta Gesù, che si svolge in un breve arco di tempo: tra due e tre anni e non di più, ma agitando temi e suscitando attese vivissimi nell’ambito ebraico dell’evo, e raccogliendo una eco vastissima.
Osserva Giovanni Garbini che tra la predicazione e morte di Gesù e la trascrizione in un corpus di scritture della sua predicazione passa circa mezzo secolo, ma durante il quale, sempre secondo Garbini, l’insegnamento originario di Gesù, quale il filologo desume da sparsi indizi negli evangeli, subisce una profonda trasformazione.
Al centro dell’insegnamento di Gesù c’è, per Garbini, un messaggio di amore e pacificazione universale, che ha il suo culmine nell’insegnamento del Padre Nostro, ripresa ebraizzata dell’inno a Zeus dello stoico Clenate. E c’è soprattutto nella predicazione del Gesù storico, quale Garbini coglie da sparsi elementi, un sistematico appello unitario ai due generi maschile e femminile, le donne il grande canale non solo della diffusione, ma della conservazione del messaggio d’amore del Gesù, il cui insegnamento si ispirò al ‘Cantico dei cantici’.
La costante presenza, pur entro la normalizzazione in senso maschilista della tradizione evangelica, dell’elemento femminile, la fede in Gesù che dal femminile parla in modo altamente significativo in vari episodi e nel finale compianto ai piedi della croce, dicono quanto il messaggio formalizzato in nuova religione del maestro Gesù, rispetto al tempo zero della sua predicazione, sia stato in parte adattato ad esigenze nuove, che trasformano, nell’arco del mezzo secolo che va dalla sua morte ai primi evangeli. Nei testi evangelici il racconto storico non è ormai che il calcolato supporto pensato: progettato in funzione della costruzione d’una ormai affermata tradizione mitica, la cui compiuta sistematizzazione cogliamo già nella predicazione dell’apostolo Paolo.
Intorno a Gesù, nel mezzo secolo tra la sua morte e la stesura degli evangeli, entro una cerchia di israeliti, si verifica una doppia assimilazione del Gesù storico con due figure mitiche della tradizione religiosa semita come definitasi nell’ebraismo.
Israele viveva l’attesa del messia: il liberatore dal dominio romano, che avrebbe dovuto consegnare il mondo ai figli della luce.
Israele celebrava il culto sacrificale del re morto per il suo popolo in forma ormai universalizzata nel rito della pasqua con il sacrificio dell’agnello, dov’era emblematizzato anche il sacrificio del re , la cui ultima incarnazione era stata quella del re assassinato Zorobabele.
La trasformazione della figura storica di Gesù in divinità avviene attraverso la doppia combinazione del mito del messia, d’ambito esclusivamente ebraico, e del sacrificio del re, di più vasto ambito semita, che si saldano e producono il mito cristiano, come ci è giunto attraverso il rito della messa, posteriore di oltre un secolo alla morte di Gesù e alla sua apoteosi nel Cristo, ovvero l’unto, tipico rito delle regalità semite.
Il rito della messa si determina in ambito, spiega Garbini, nord africano, entro la chiesa cristiana sorta intorno a Cartagine, dove si conservava particolarmente vivo il mito del sacrificio. Nella messa si celebra la morte e resurrezione di Gesù, ostia sacrificale e redemptor mundi, venuto a salvare tutti quanti credono in lui, secondo l’insegnamento che già troviamo nll’apostolo Paolo, la cui predicazione pone una questione strategica decisiva.
La predicazione paolina è antecedente alla stesura degli evangeli, e predica una teologia di salvazione universale messianica altamente elaborata, nella quale, escluso il rito della messa, ma una cui prefigurazione si trova già nel pasto comunitario, durante il quale si sparisce il pane e il vino come corpo e sangue del Cristo, tutta la trasformazione mitica della figura storica del Cristo è già consumata, trasformando Gesù nel messia, il ‘redemptor mundi’, re sacrificale immolatosi per il riscatto dell’umanità.
Il vero enigma del cristianesimo sta in questa trasformazione, che si è consumata del tutto entro la cultura religiosa ebraica gerusalemmita, tra la morte di Gesù e la predicazione di Paolo: nella tradizione l’apostolo che predica tra i gentili il messaggio di Gesù, lo estende oltre l’ambito ebraico. Altro luogo mitico che Garbini confuta, rilevando come, dai dati attestati, Paolo predica sempre in comunità ebraiche entro l’ambito di locali sinagoghe. La qual cosa non deve sorprendere. Il monoteismo ebraico era una religione in forte espansione nell’impero, intorno alle locali sinagoghe.
Il Costa, nel suo classico libro sugli ebrei nell’impero romano, stima che i praticanti del culto monoteista yhavetico, all’epoca di Tiberio imperatore fossero tra i cinque e dieci milioni, ergo tra il 5% e il 10% dei sudditi dell’impero. Entro questa massa altamente strutturata in comunità di locali sinagoghe irrompe, emanata, se non dal tempio centrale di Gerusalemme, almeno dal suo ambito, e quindi altamente attendibile, la nuova forma forma di monoteismo ebraico, nella quale si annuncia che il messia è venuto e si è sacrificato per la redenzione di tutti quanti credono. Il linguaggio è tutto interno e coerente con il yhavetismo gerusalemmita, che attende la venuta del messia e predica il culto sacrificale con il rito pasquale.
Il punto, osserva Garbini è: quale raffinata mente teologica ha riunito nella figura del Gesù storico i due miti del sacrificio e del messia trasponendola nella spazio mitico?
Al centro di questa trasposizione c’è la coincidenza del tempo storico della crocefissione di Gesù con il tempo mitico pasquale del sacrificio dell’Agnello. Il costruttore del cristianesimo, la mente che ne ha creato la dimensione mitica trascendente, entro la quale ancora oggi il cristianesimo si disloca, ha realizzato il passo decisivo facendo coincidere il tempo storico del processo a Gesù, con il tempo mitico del sacrificio pasquale, a trasformare un uomo condannato dalla giustizia romana per sedizione e quindi crocefisso, in redemptor mundi.
Forse la ragione dell’assenza di notizie sul Gesù storico sta tutta qui: nella condanna di Gesù alla crocefissione; condanna che lo segnala come rivoltoso politico e quindi quasi certamente aderente ai circoli di zeloti. I romani crocefiggevano soltanto gli schiavi fuggiaschi e i rivoltosi politici, e il Gesù storico era un rivoltoso politico, ma questo poteva rendere estremamente pericoloso celebrarne pubblicamente un culto di tipo eroico, come accadde nella cerchi dei suoi seguaci, quando si diffuse la fede nella sua resurrezione e ascesa al cielo.
L’impero romano non poteva tollerare l’eroificazione cultuale d’un rivoltoso dell’impero, mentre proprio questa rivolta doveva rendere la figura di Gesù: il suo martirio sacrificale, particolarmente suggestiva in alcuni ambienti teologici gerusalemmiti, che dovevano aver seguito e aderito alla predicazione dottrinale del Gesù storico, soprattutto in forma di dottrina d’amore universale, che aveva già un vasto seguito ante Gesù, come testimonia la canonizzazione del testo del ‘Cantico dei cantici’.
Possiamo anche congetturare, andando oltre il testo del filologo e le sue deduzioni, che l’insegnamento del nuovo profeta Gesù suscitasse forti contrasti e tensioni, e una fazione del tempio usasse lo stato romano per liberarsi dal predicatore di una pericolosa dissidenza che stava raccogliendo troppo successo. Ma questa dissidenza non si spense con la condanna politica di Gesù, determinò invece una esaltazione della dottrina d’amore intorno a un Gesù asceso dalla storia al mito e come messia e come agnello pasquale, attraverso la dislocazione del tempo storico processuale nel tempo mitico pasquale.
Questa irruzione di un nuovo racconto mitico, nei suoi elementi sintattici coerente con la tradizione gerusalemmita, viaggia nel ventre del circuito delle sinagoghe, fino a determinare forti contrasti tra gli ebrei che ritengono il messia venuto e asceso attraverso l’apoteosi del martirio sulla croce a redemptor mundi e gli ebrei ortodossi che vivono ancor l’attesa del messia, determinando conflitti violenti locali, uno dei quali, ci riferiscono Tacito e Svetonio, quello scoppiato a Roma, e che induce l’imperatore Claudio a decretare l’espulsione di tutti gli ebrei da Roma.
Un conflitto che porta a scissioni entro l’ambito delle locali sinagoghe e alla nascita d’una coscienza cristiana separata dalla tradizione che l’ha espulsa, come documenta tutta una riscrittura in senso anticristiano della tradizione biblica, che approda nel testo noto come masoretico.
Per i cristiani, non riusciti a diventare maggiorana in ambito ebraico, diventati una setta minoritaria, si pose il problema di costruire un culto eroico del Messia che non urtasse contro il maglio repressivo dello stato romano. Questo si realizza con la scrittura degli evangeli, che introducono la valenza compromissoria intorno al decisivo apologo del ‘date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio’, per cui le tasse vanno pagate a Roma, prima mossa di quel processo di penetrazione nelle popolazioni dell’impero che procede dai centri metropolitani, secondo la logica di diffusione di tutte le grandi religioni storiche: sorgono in centri urbani e solo dopo penetrano nelle aree agricole.
Al trar delle somme, non deve sorprendere il silenzio sul Gesù storico: che si dissolve nel momento stesso della sua crocefissione, con la quale avrebbe dovuto concludersi la sua parabola politica e umana, come infatti si concluse. Ma accadde che tra i suoi seguaci si diffuse il racconto della sua resurrezione e ascesa al cielo. Cosa perfettamente credibile in ambito religioso ebraico, dove alcuni profeti erano ascesi al cielo, e l’ostia sacrificale era mandata a impetrare, dai tempi arcaici, le divinità infere, ed ora il dio celeste unico Yhavè.
Il processo di eroificazione del Messia non poteva che coinvolgere all’origine circoli ristretti, e agitare contrasti interni alla comunità israelita, il Gesù storico del tutto figura senza interesse, sopraffatto dal Cristo asceso nella sfera del mito a Messia e redentore universale nella forma di ostia sacrificale.
Solo quando questa nuova fede ebbe acquistato dimensione rilevante, e ci fu in ambito ebraico chi forse cercò di negare la figura storica del Cristo, sorse la necessità di recuperarne, a mezzo secolo dalla sua morte, la figura storica concreta, per la crescente massa di credenti d’ambito soprattutto semita extra ebraico, dove il substrato religioso arcaico del re sacrificale trovava immediato consenso nel nuovo dio. I vangeli sono anche la risposta alla crescente necessità di dare una concreta visione a una comunità in rapida espansione, anche a stabilizzarla, del tempo delle sua origine e irruzione nel mondo a redimerlo prima del ritorno del Messia a giudicare il mondo; comunità cristiana che sappiamo viveva, e la cui predicazione traeva forza da una spasmodica attesa apocalittica, d’una fine dei tempi vicina, nella sostanza non diversa dalla spasmodica attesa del trionfo del comunismo che pervade il XX secolo.
E in questa necessità di apocalisse si inserisce l’episodio dell’incendio della nuova Babilonia orchestrata dai credenti nel Cristo, l’incendio cristiano dell’evo neroniano.
Come il bolscevismo, come l’islamismo, prima di diventare religione di stato e praticare dai centri di potere statale la repressione, anche il cristianesimo è passato per una sua fase terrorista, ma contenuta e limitata, per la reazione violenta e spietata della macchina imperiale romana, proprio per evitare la cui aggressione devastante, il cristianesimo rapidamente passa dalla dimensione millenarista apocalittica alla dimensione fraterna amorosa universale, ma la dimensione aggressiva milenarista rimasta in fieri nel corpus della tradizione, sempre pronta a riemergere dai suoi visceri.
La dimensione violenta millenarista si rivela in tutta la sua violenza aggressiva quando il cristianesimo, come ogni altra religione entra in combinazione storica con il potere politico, diventa elemento chiave per il sostegno della struttura stato, nutrita del prelievo fiscale che attraverso questa macchina passa.
Piero Flecchia