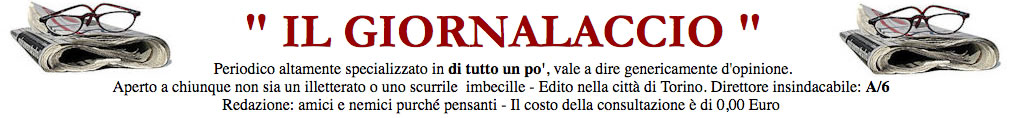“La regola dell’orizzonte” e il nostro vigile essere-al-mondo
“La regola dell’orizzonte” e il nostro vigile essere-al-mondo
Come scrive la stessa autrice, questo libro (Edizioni Puntoacapo, 2018) esce a sei anni di distanza da “La pazienza dell’inverno” (2013). Da allora molte cose sembrano essere cambiate. La più importante, nel contesto di questa nostra lettura, è l’emergere della “tendenza a comporre micro-sillogi, non più poesia singole”. Questo porta “a selezionare maggiormente le immagini”, ci dice Alessandra Paganardi. E di un libro di immagini in poesia qui si tratta. E’ come se la parola si mettesse al servizio dell’immagine che la parola vuole evocare, identificare, rivelare. Un tempo le fotografie attraversavano il percorso che dallo scatto portava allo sviluppo e poi alla stampa mettendo il fotografo nella condizione di poter in qualche modo intervenire, modificare in modo artigianale l’immagine.
Alessandra Paganardi rivive questi processi applicandoli alla poesia che si organizza in questo libro attorno a sette micro-sillogi che hanno appunto l’aspetto di cornici-contenitori poetici di immagini, di scatti visivi che ci propongono un timbro, un colore, un tono poetico sempre diverso eppure chiaramente figlio della stessa mano, dello stesso sguardo seguendo, appunto come dice il titolo che rinvia alla prassi fotografica dell’inquadratura, la regola dell’orizzonte.
Ma questa scelta di fondo, strutturale per così dire, non avrebbe senso se non poniamo attenzione, come già anticipato, ad un altro elemento di novità. La scrittura, l’organizzazione del verso, l’approccio epistemologico e stilistico dei testi, tutto è segnato da una volontà visiva. Alessandra Paganardi, con evidente maestria, si abbandona al fluire della lingua e delle immagini, lascia che la sua scrittura s’impregni della forza evocativa della presenza delle immagini stesse. Attenzione: siamo lontani da una poesia “visionaria”, astratta e fantasmatica. Tutto è terribilmente presente, concreto, legato all’esperienza del reale.
Certo la capacità metaforica, il controllo dei passaggi significanti, i salti poetici che intrecciano visibile e invisibile, razionale ed intuitivo, presenza e ricordo ci offrono un testo talvolta straniante, altre volte onirico. Ma sempre ancorato all’esperienza. Alessandra Paganardi poi non rinuncia affatto alla sua solida vena meditativa, alla sua capacità aforismatica di cogliere la realtà nel tratto mediato del pensiero che dà ai suoi testi una risonanza meditativa. Questo libro si colloca felicemente sul versante di quella poesia che supera le sterili dicotomie tra emozione e pensiero e lo dimostra, a mio avviso, il fatto che l’autrice non si abbandoni mai a facili “emozioni” quanto piuttosto si soffermi e si sforzi proprio di offrirci il percorso della complessità della sensazione, del riflettere sulla articolazione degli stati dell’essere.
L’interiorità vigile e pensosa della poetessa attraversa le esperienze della gioia e dell’angoscia, esplora le dimensioni delle età della vita, ci apre al mondo delle sue passioni e dei suoi riferimenti letterari con gli strumenti di un “soggettivismo lirico” inedito che non si ripiega su stesso, che non cede mai alle facili soluzioni egotiche, ma che mantiene uno sguardo “strabico”, volto verso qualcosa che sta e va oltre l’immediato, ricongiungendo la poesia al mondo reale. Come ogni poesia importante non si deve cercare di capire tutto e subito, al contrario il lettore deve lasciarsi andare ai colori, ai suoni, al passaggio delle parole (si noti che Alessandra Paganardi non usa mai né virgole, né punti e che ogni singola poesia finisce così per essere un testo aperto, una finestra sulla successiva poesia, in un richiamo continuo) scoprendo a poco a poco che tutto è necessario, tutto è messo al posto giusto.
La prima micro-silloge è “Mare apparente”, serie di “notturni” che rinviano alla dimensione del passato-presente, in cui le poesie sono brevi sospensioni di un flusso esterno, spazi protetti in cui riemergono relitti, reperti, isole d’affetti e di storie. Immagini in bianco e nero della coscienza che nascono dai ricordi, dalle sensazioni in una dinamica di razionalismo lirico-sensoriale.
“Se confondi le piazze i portoni/è perché tutti i posti sono ovunque” scrive AP che subito supera lo smarrimento “ritrovare nelle suole/l’insegna dimenticata/ di quel lontano innamorato aprile”. Genova (che non è la città d’origine dell’autrice, ma che ha evidentemente un significato affettivo importante irrompe sulla scena e subito affascina e rapisce: ”non ti aspetti una città così vicina/vinta da odori senza più pudore/- un mare che sparisce nei cortili/fritture clandestina“, Genova (che già fu città di Giorgio Caproni livornese di nascita) che non ti lascia andare via “non tornerò – dicevi – / la bellezza ti ha tagliato via/ sei rimasto per sempre”. E nell’aggrovigliarsi degli aggettivi e d’immagini sensoriali, AP ci restituisce un istante vissuto che è anche la descrizione della stagione in cui quella città entrava nella sua vita: “Il sole finalmente disarmato/ la gelida carezza dell’eclissi/…sorreggevi un silenzio/ nella resa delle palpebre/il muro è ritornato abbraccio/accade un ombra amica/ tu la chiamavi estate”.
Se gli echi di Caproni e Sbarbaro cominciano a far breccia, è il milanese Milo De Angelis a far da sponda quando AP scrive “L’albero è capovolto/le radici nel blu/il nero la sua chioma/…bisogna avere cura anche del nero/crescerlo come un fiore/…preparare l’invaso nell’azzurro”. L’esperienza esistenziale dell’angoscia è qui metaforicamente espressa con immagini imprevedibili ed originali. Più “classico”, ma non meno efficace l’incipit “La notte trasforma tutto in poco/ non sai quando saranno/le prove generali per il niente/”; oppure si veda la cura nel cogliere microcosmi nell’apparentemente invisibile “Uno stridore di corteccia/la falena barbagianni scontava/ la disonesta affinità con l’albero/… la spigolatura fu /una chimica azzurra/il giardino tornato origami”. Poi è la volta di un salto ancora nell’infanzia più volte evocata: “E’ una ferita la gioia/lascia sul muro lo schiaffo di un’ombra…/ per questo da bambino/dopo il frastuono delle risata/ti guardavi le vene”. Quindi ancora il senso esplicito per il pensiero poetico: “la fedeltà all’istante/non ripete mai il viaggio/il flutto inevitabile/lascia sempre lo scoglio diverso/la risacca testarda/sa di ritrovarlo uguale”. E per finire AP esprime una forma di consapevolezza legata alla propria condizione di poeta e, forse, di donna: “s’inteneriva la traccia/rimestava il confine/finalmente hai capito di abitare/dalla parte storta del cielo”. Già in questa prima parte si coglie la capacità di AP di controllare i registri poetici che intrecciano temi diversi, che utilizzano approcci tonali polimorfi pur restando sempre perfettamente coerente e riconoscibile.
Segue “Angeli guardiani”, una micro-silloge più metaforica che fa riferimento all’immagine dell’arcangelo Raffaele, angelo della guarigione. Qui le poesie sono passaggi d’immagini da gustare nella risonanza della loro forza. E’ come se AP avesse ingaggiato con se stessa una lotta (così come fece il biblico mGiacobbe, preoccupato per la sorte del fratello Esaù, con l’Angelo incontrato sulla via) per trovare le parole giuste, per dire ciò la voce della poesia stessa vuole dire. Nascono così versi quali: “la distanza si era fatta traliccio”; “La mente si fa labbra – /tutto l’arcobaleno bevuto/ nei sorsi disperati dell’infante”; “Sconteremo questo troppo giorno/ la pelle arresa ostaggio della luce”; “questo giorno che non ha conosciuto/santi ma solamente primavera/tu non segnarlo più sul calendario/non obbligarlo di nuovo a morire”.
C’è una tensione sul tema del tempo, del vivere attraverso i passaggi della nascita, dell’infanzia, degli addii, ma ci sono anche due testi che a me paiono molto significativi. Uno ispirato all’angelo di Paul Klee, l’angelo della storia al quale la poetessa chiede “girami il volto dalla parte giusta/ la mano destra del pensiero chiaro/…” e di “guardare avanti dove il tempo scappa/contromano alla gioia sopportare l’assurdo/ che amo”. Assurdo che è la poesia stessa, sguardo sghembo di una condizione “diversa” di cui AP è consapevole: “invece sono qui con le parole/che appendo lungo i muri/ di una periferia color del sale”.
Nove sono le poesie de “Il resto della vita”. Il metodo iconico entra nel lessico stesso e troviamo subito immagini quali “Gli occhi della moviola stendono/campi lunghi su filari guariti/ e la stessa terra ci guarda con gli occhi pazienti dei morti”; oppure incontriamo “un monogramma impresso in dissolvenza”. Ma quel che conta è ancora la tensione che AP crea tra l’azione della scrittura, la riflessione sull’essere poeta e l’esperienza della realtà. Scrivere è un “duello di sillabe/ a fil di spada con il tramonto” che permette di cogliere il momento in cui “una lanterna magica/ riempie il cielo di fuochi taciturni/in un gioco di stelle vagabonde”.
La vocazione della scrittura è un demone che “ti sbriciolava il sonno/la sorpresa di un verso inaspettato/come un abbraccio/come un dolore” , una manifestazione sincera di adesione alla propria “condizione” di poeta che trova una bella espressione nella capacità di AP di produrre in questa raccolta dei quadri poetici di parole come fossero delle nature morte pittoriche: “Piccoli morsi d’ape/hanno piegato i fiori blu/la superbia del cielo s’inchina/al tocca della vita inevitabile/ è un melograno spaccato/questa bocca arresa alla tua/l’eredità fatta dimora/del primo autunno sontuoso”.
Il tema della scrittura permea la micro-silloge successiva “Monogramma” ispirata esplicitamente alla poesia di Antonia Pozzi. “Poesia che mi guardi” scriveva Antonia, che era anche fotografa, “da piccola inseguivo le parole/erano loro a correre sul foglio” scrive AP; Antonia era tormentata e geniale, per certi versi esclusa e AP scrive a sua volta :”la chimica testarda del carbonio/non si stancava di rifare mondi/ dove non ero stata mai prevista/”.
Non è tanto quindi lo stile in sé ad accomunare le due AP, quanto l’ideale corrispondenza dello sguardo e la volontà di seguire una vocazione scritturale: “le parole mi fermentavano in bocca/sono cristalli d’argento nel fango/bisognerà aspettare/…aspettarle pazienti/con stupore d’amante che sorveglia/la gioia di una donna”. In questo modo la poesia produce uno scambio di immagini, un fluire di identità da una all’altra in un gioco di specchi letterari. “Non c’è niente più buio/del male di parole/la parola abita mondi strani/rappresi nelle pagine di un libro…” è male d’universo/questo mal di parole”. E dopo troviamo “Lentamente il suo volto/ scardina il mio pudore/è una conquista d’occhi/randagi fissi altrove…L’odore dei suoi sogni/riempie di terra i solchi fra le nuvole/ e le stagioni passano/mentre il cielo s’inclina”.
AP scrive così una sorta breve cripto-biografia lirica di Antonia Pozzi, dolente e partecipe, ne fa un ritratto umano e poetico a cui ella stessa s’ispira: “amo le tazze sbrecciate/le lor crepe familiari/dicono la fatica incandescente/dei tramonti nel chiuso di un solstizio”; “dal ramo non sospetti la ferita/poi tocchi il frutto e lo senti grave/ più fragile come per troppa vita”; “ho fermato il tuo passo nello scatto/prima che l’acqua e la pietra/diventino la voce del saluto”: “Cammino dentro il vuoto dei tuoi passi/orme che avvolgono le mie”…sei la bussola tesa alla sua cima/sotto un cielo affamato”; “nel fondo dei tuoi occhi/ si è rovesciato un golfo di domande/ ci ha incollati la notte/al debito insoluto d’assoluto/all’addio condonato – alla rapace/vorace vita”.
Lo scambio di persona, un giro di sguardi, non solo un pre-testo poetico, ma una strategia per cogliere il momento critico della scrittura e del suo gesto creativo: “ho messo tutti i libri sul cuscino/mi sveglio dentro un sogno di parole”; “il parto è qui/un prodigio di secoli immobili/un canto fatto pietra”; “restami libro amico/rifugio caldo di ogni carta da gioco/scompaginata/conficca dentro il fianco la parola/come dopo una corsa/si fa stella il dolore”. Versi di poesie diverse che però sembrano tutte emergere dallo stesso unico testo.
“Il codice di vetro” ha già nel titolo il senso della fragilità che AP vuole comunicarci. Ma non è mai una fragilità lamentosa, scontata. La fragilità di cui ci parla AP è quella di chi si pone in maniera obliqua rispetto alla realtà, di chi è capace di cogliere, come diceva il pittore Franz Marc grazie ad una sorta di “seconda vista”, elementi del mondo facendoli così riemergere “in un altro luogo”, quello dell’anima. Le dieci poesie che compongono questa micro-silloge sono fotografie di attimi dove però si riconcentrano tutti i temi fondamentali della raccolta. L’io poetico vive nell’attimo, fuori dal continuum del tempo, portatore di una visione speciale che è kairòs, irruzione d’un lampo “vivi soltanto per un attimo/gravidi d’abbaglio e di furore/prima di ritornare invisibili” e così capaci di sottrarsi alle banalità e “andarsene nel mezzo della festa/ stupire come un grande arcobaleno” verso che ricorda certi passaggi di Wislawa Szymborska.
E di nuovo torna il piacere di accarezzare il ricordo dell’infanzia, terra della possibilità e dello stupore, della grazia melanconica “Questa strada tra le case/ha il nome di biscotti frettolosi/nel latte prima della scuola”. E torna anche il tema della gioia desiderata, sfiorata, assaporata, da proteggere: “sia cara al cielo questa nostra gioia”…”Quando cercherai/quella crepa sul viso/ la chiave arrugginita di un sorriso/ e l’amerai come se fosse gioia”.
Non manca poi l’emergere del tratto gnomico: “Il dono della spiaggia è questione di tempo…/la risposta che tutto ciò che è perso/aspetta sempre altrove”; oppure si veda il verso molto bello “non siamo stati mai degni del vuoto/che tradivamo”. Così come resta fisso il tema della parola e della scrittura quale spazio protetto e rischio felice al tempo stesso: “Avere stretta in gola una poesia/e non scriverla ancora/aspettarlo come sulla spiaggia/fanno le donne coi pescatori/…salutarla se passa per tornare”. E c’è il tema del dolore, contrappunto della gioia, a scandire il passo poetico di AP: “Chiedilo al verderame/all’anima viscosa di petrolio/veleno per il male/ ti dirà che il dolore è nelle foglie/le loro vene contorte di fame/ lo sanno che la vita non guarisce”.
“Il peso del vento” ci riporta a Giorgio Caproni esplicitamente citato in esergo. Ancora una volta il riferimento serve a dire una linea, un orientamento senza che vi sia, naturalmente, forma imitativa. Il vento qui è metafora del movimento a tutto campo della poesia, che spazia tra passato, presente e futuro (“il vento ha riportato tutto indietro”, che accompagna il transito dei pensieri, che li scombina (…”nella fornace dove tutti i colori/si mescolano senza bocca né mani” …”), li accarezza. Naturalmente ci sono immagini molto belle che caratterizzano incipit convincenti e curati. “Vicoli magri ingoiavano luce…”; Era largo il mattino/pungeva la sua luce/come il primo spuntare do un senso/”; “la notte mette il mondo nella testa/ e lo straccia nel buio”; così come le chiusure hanno il gusto della parola definitiva, del limite insuperabile: ”la terra pesa quando il vento ha fame”; “di notte i versi ritornano cifre/ nel libro mastro degli amori finiti/scendono in un bilancio clandestino/che non trova riparo”.
Chiude il libro “A termine”, quattro poesie in cui AP mette in chiaro che tutto il percorso sin qui svolto ha una spinta etica fondamentale che ha nella poesia, nella caparbia ricerca espressiva della parola un suo strumento necessario. AP ritiene la poesia un compito essenziale della nostra humanitas, un dono ricevuto e, a sua volta, da restituire, da condividere, la cui pratica quindi non rende estranei al mondo, pur essendo il poeta una figura non omologabile, ma al contrario permette di rivedere e ripensare la relazione tra io e mondo in una chiave originale.
Scrive AP: “..Inutilmente continuo ad amare/l’inutile tuo dono/resto con le mie piccole parole/bellezza cerco in mezzo alle rovine” ; e ancora. “Rimango al limite della gioia/che non chiede mai il conto/di questa splendida imperfetta luce” e chiude con questi bei versi: “tutto quell’oro vorrei regalarti/per medicare il buio/per guarire la terra/per cucire pazienza sui ricami/se un giorno non avremo più le mani”.
Una prova quindi molto convincente che ha il merito, tra gli altri, di mettere al centro l’idea che la poesia è un’arte preziosa proprio perché ci mette in contatto con “il doppio fondo scuro” di noi e del mondo, poesia che però è anche “l’attimo prima del suono”, perché è la parola che esprime il nostro essere, parola che è «quello stare sospeso dentro un niente / tra l’arco e la sua freccia», parola che non è flatus vocis ma spazio utopico, pre-apparizione del possibile, rischio di gioia e al tempo stesso segno della lacerazione interiore che non uccide, ma che testimonia del nostro vigile essere-al-mondo.
Stefano Vitale
@@@
Note sull’Autrice
Alessandra Paganardi è nata nel 1963 a Milano. Attualmente è presente nella redazione della rivista letteraria internazionale “Gradiva”, nella giuria del premio omonimo e in quella del premio “Gozzano”.
Ha tradotto autori anglofoni e francofoni fra cui: Carnevali, Breton, Barnes, Braque e Stevens. Ultime raccolte di poesie: La pazienza dell’inverno, Puntoacapo 2013 (premio Operauno), Tempo reale, Joker 2008 (premio San Domenichino 2009); Ospite che verrai, Joker 2005, (ristampa 2007).
Per Puntoacapo Editrice ha pubblicato (2019) la raccolta intitolata La regola dell’orizzonte. Plaquette: Frontiere apparenti, Puntoacapo 2009; Vedute, Ibiskos Ulivieri, 2008; Binario provvisorio, Seregno 2006; Potevamo dire l’assenza, Crimeni, 2005.
È autrice di Saggi critici, aforismi e narrativa. Ha vinto i seguenti Primi Premi per la poesia: “Europa in versi” (2016); “Alda Merini” (2013), “Astrolabio” (2009), “San Domenichino” (2007 e 2009), “G. Gozzano” (2007), “D’Annunzio e la Versilia” (2007), “Dialogo” (2003).
***