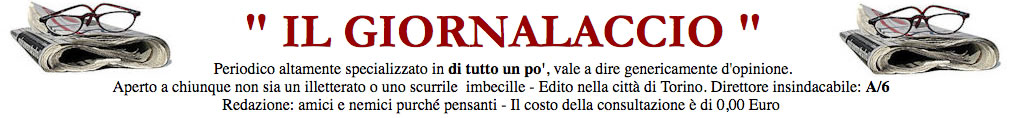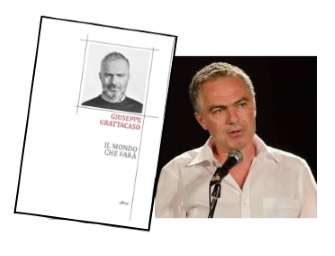 In un’intervista Giuseppe Grattacaso, parlando della propria poetica e riferendosi alla sua raccolta del 2013 “La vita dei bicchieri e delle stelle” (Campanotto Editore), ha detto:
In un’intervista Giuseppe Grattacaso, parlando della propria poetica e riferendosi alla sua raccolta del 2013 “La vita dei bicchieri e delle stelle” (Campanotto Editore), ha detto:
“Credo che la fisica del Novecento, in particolare offrendo una nuova immagine dell’universo, abbia cambiato il modo di intendere l’esistenza, ci abbia costretto anche a rivedere il senso della nostra presenza nel mondo. In ogni caso, più conosciamo l’universo, più lo sappiamo esteso: ne deriva che, paradossalmente, cresca anche la zona di cui sappiamo poco o nulla. Così gli oggetti che ci accompagnano nella nostra vita quotidiana, i bicchieri, le sedie, le lampadine, gli elettrodomestici, finiscono per essere una sorta di ancoraggio, ci offrono l’illusione che non siamo dispersi in un angolo remoto e insignificante dell’immensità, assumono un ruolo salvifico: possiamo collocarli secondo un certo criterio, ad esempio, e con questo credere che un ordine sia possibile, che da qualche parte esista un progetto che spieghi la nostra esistenza. Inoltre gli oggetti fanno parte delle nostre vite e rappresentano i nostri affetti molto di più di quanto siamo disposti a credere. Siamo capaci di affezionarci a una tazza, di arrabbiarci con una lavatrice. Il libro parla soprattutto di questo, del legame strano e indispensabile, tra il lontano e il vicino, tra le stelle appunto e i bicchieri. Le poesie sono composte quasi interamente in endecasillabi, che però si sviluppano in un tono colloquiale, un registro volutamente tendente al basso. Mi piace molto quando la poesia crea un cortocircuito linguistico, per esempio tra musicalità del ritmo e quotidianità del lessico”.
In questa lunga citazione ritroviamo il senso dell’ultima raccolta di Grattacaso appena pubblicata da Elliot col titolo “Il mondo che farà”. E ci colpisce la lucidità del poeta nel descrivere la propria intenzione, nell’indicare la direzione che intende seguire e che in effetti egli segue. Non è da tutti. E ciò rivela una maturità ed una consapevolezza letteraria molto significativa nel variegato e frammentato panorama della poesia in Italia oggi.
La postura poetica di Grattacaso, che si avvale di una sensibilità ritmico-musicale nella costruzione dei suoi versi, che connette continuamente il lontano e il vicino, che utilizza un lessico quotidiano per esprimere pensieri e sensazioni esistenziali profonde, ha un una passo apparentemente svagato, da flaneur d’altri tempi (“un certo giorno uno camminando/per una strada che non riconosce/ o nell’attesa di un treno alla stazione/in leggero ritardo o all’improvviso/ rimasto frastornato/ senza mira/ davanti ad una vetrine…/”). Tuttavia, così facendo, il poeta aguzza la vista e focalizza d’improvviso la sua attenzione su particolari “oggettivi” inattesi (…percepisce/ senza cura il destino, che la vita//più non funziona che per struggimento/,/ per insolvenza”.
E’ come se lo sguardo poetico nascondesse, dietro la maschera dell’incerto, dell’uomo distratto, un rapace osservatore della realtà. Ma ovviamente il poeta non s’accontenta della superficie delle cose. Quel che gli interessa è cogliere il movimento, più o meno apparente, delle cose; afferrare il nocciolo delle situazioni. Ma non basta: in quel cercare di trattenere il divenire, il manifestarsi della realtà, il poeta scopre che il senso delle cose (e dell’esistenza, cosa tra le cose) sta proprio in una zona intermedia, negli interstizi del chiaroscuro, nella sua capacità-possibilità della sospensione, dell’epochè fenomenologica che così esprime l’erlebnis, il vissuto dell’essere-al-mondo. Infine, questa sospensione, riguarda anche il poeta stesso che solo rinunciando al frastuono delle distrazioni (“ Gli altri vanno dritti/ e lui scantona ed abbandona il gruppo, elimina le chat, senza parole/ rimangono le immagini…”) riesce ad accedere a quel punto intermedio, a quella zona franca della riflessione che è esperienza diretta della vita (“lui aspetta un nuovo tempo non più pioggia/, i temporali, acciacchi, altri malanni/ma vento che rischiari il paesaggio”). Una visione ragionante o, se volete, un concetto che si fa forma poetica, slancio sentimentale che è anche pensiero lucido del negativo: questa la mia lettura di questa bella raccolta di Giuseppe Grattacaso.
Questo approccio mi pare attraversi coerentemente tutta la raccolta costruita su sillogi unitarie che, appunto, si presentano come specifiche variazioni sul tema dominante. I testi sono un viaggio tra il quotidiano apparentemente scontato e insignificante (“la frutta in bella mostra nei mercati”) e la folgorante riflessione esistenziale (“salvarsi è rimane nella fila/sentirsi al proprio posto nella serie”); oppure ci raccontano metaforicamente il nostro disagio contemporaneo lenito dallo stare “a proprio agio nella sospensione/del tempio traballante del mercato” o espresso nell’indecisione senza fine: “a volte resto fermo accanto a un banco/ non so che fare, guardo oltre la frutta/ dovrei comprare e invece resto fermo,/me ne sto zitto, come se quel punto/fosse in eterno il solo punto fermo/..un buco nero…tutto intorno/ s’agita diligente tanta gente/ che sta sul precipizio e non lo sa”.
Il poeta sente che “la vita certe volte ci scorre accanto” e per evitare di essere travolti occorre attivare strategia speciali quanto semplici: “mi addormento/ se lei corre di lato, o faccio finta/ che sono assente e non mia la vita”.
Nel gioco tra enormemente distante e incredibilmente vicino prende spazio la riflessione che oscilla tra dimensione stellare, cosmica e vita quotidiana. Pluton Portrait ha questa funzione di straniamento che paradossalmente avvicina “per l’eterno giro/lontano da ogni centro” e che in fondo rassicura restituendoci un paradossale spazio di umanità: “Se cresce l’universo toglie spazio/può darsi a qualche cosa che non c’è/stravagante teoria: se difetta/materia che giustifichi il confine, /manca il confine e dunque manca l’oltre”.
La questione si fa “teologica” e laicamente si trova una diversa soluzione: “Se c’è davvero un essere pensante,/la mente ordinatrice che controlla/ il buon funzionamento/non è detto/stia pensando per noi” e ricordando Giorgio Caproni scrive: “… Può darsi che il supremo/sia già troppo impegnato a superarsi,/in lotta con se stesso senza posa”… L’invito qui è di considerare meglio la necessità di controllare gli istinti nichilisti (che vedremo riemergeranno più avanti) e cercare di essere come l’ortensia (controfigura della leopardiana ginestra?) che vive meglio ogni sei mesi “perdendo forza e poi recuperando/ lo smalto ed il vigore, giovinezza / in ogni petalo… tutti vecchi,/ tutti giovani insieme, senza linfa/… nel corpo che non tema senescenza” .
La vita procede senza posa, “tra poco più di un secolo nessuno/degli odierni viventi sarà tale”, così “tanto vale / adattarsi alla recita virale, non chiedere perché il programmatore/ non cambi mai l’immagine finale”. Una forma di neo- stoicismo etico viene qui proposto visto che “non c’è altra contrada/ che quella esatta dell’inconcludenza /inutile virtù della partenza”. Meglio rendersi conto che la meta non è mai nuova terra, “ma lo smarrimento/ d’essere soli”, che è più forte la fantasia del viaggio che il viaggio stesso, che le nostre proiezioni sono forme del desiderio spesso inutilmente fallaci “noi aspettiamo/ di tracciare la mappa della notte, /ma il cielo cresce in ogni direzione/ in corsa inconcludente”.
Il poeta preferisce dunque lo stare in bilico, quale forma paradossale di protezione dal fluire delle cose; il poeta cerca le situazioni di passaggio, di sospensione, quando niente è ancora davvero concluso, deciso: “noi volevamo prima dell’inizio, /quando nessuno vince e il tempio arranca/senza destinazione” anche se purtroppo “invece arriva/ sempre un fischio d’inizio, un campanello/ che ci porta feriti oltre il confine”. E’ dunque preferibile, comunque più adatta alla nostra condizione, la scelta del giallo al semaforo “il giallo ci conservi nell’indugio/l’incertezza ci liberi dal viaggio”. Ed è importante fare attenzione alle piccole cose: non per fuga intimistica, ma per cogliere i segni della nostra esistenza, “…” per trovare “il punto fermo/ che ci faccia sentire ancora a casa/ con la speranza che tazzine e brocche/ non abbiano lasciato la credenza”.
La sezione “Il mondo che farà” riprende tutti questi temi, questi passaggi con un tono lucidamente melanconico. Il poeta mantiene sempre vigile lo sguardo attento alle micro-situazioni, ai momenti di vuoto apparente e lo fa con un lessico ed uno stile che cripto-citano i testi di Umberto Fiori: “Quando il treno rallenta e nel tremore/ della carrozza si alzano gli sguardi/ finalmente sospesi e negligenti/ allora certe di lontano/una casa un giardino un punto morto nel mezzo di una strada ci reclama”. Per poi suggerire che “la pienezza del vivere, il sorriso/ è un edificio che non rivedremo”. E ancora ritroviamo l’approccio liberatorio da ogni presunzione di certezze nei versi “Il mondo è tutto/in questo caso frutto della mente/maldestra che produce/ con sforzo immane solamente il niente/in forma di fantasmi e avvenimenti” …la salvezza è però a portata di mano: “…ma in quale luogo, se non c’è esistenza/non c’è nessun approdo, resto fermo/ e immobile mi sento quasi eterno/ se non esisto sono anch’io nel niente, però per sempre io non sono vero, /eterno e falso, un costante zero”.
C’è qualcosa di un’antica saggezza presocratica che aleggia in questi versi filosofici, ma emotivamente significativi. La rinuncia è la salvezza perché anche “la storia è un argomento/piuttosto evanescente, un’invenzione del tutto personale…” ed è inutile “voler ritrovare/ a tutti i costi il bandolo che tiene/ insieme l’avventura del passato/ col calcolo futuro…” e la conclusione è forte: “Tanto vale/ abbandonare gli studi e la materia/ ad un destino di smemoratezza/ dare fuoco alle carte, ai documenti, /non credere alle date, trascurare/ l’ammasso irragionevole di eventi”.
Per Grattacaso la storia è irrazionale e “per noi nulla/ comunque cambierà, ci accorgeremo/ soltanto dell’intoppo ricorrente, /le assenze per partenza o distrazione, / i peccati del corpo, la fanghiglia/ lasciata dalle piogge…”. Il problema è che “il progetto si risolve in smacco, / questo da sempre”, che “la vita è un tuffo dentro una pozzanghera”, in vista di scoprire che “La comica finale ora è un dolente/ addio al mondo…” (Comica finale. Tre poesie per Laurel e Hardy).
Questo senso di lucida rassegnazione avvolge poi il finale del libro che ritorna su temi personali, e sono ancora gli oggetti della casa a dare un senso all’esistenza, a fare da specchio del nostro procedere nella vita, sino alla fine. Dietro e dentro la necessità di riordinare l’abitazione di famiglia a seguito del lutto familiare, il poeta lascia emergere la sua riflessione dolente: “prova pena/ chi entra nella casa ancora piena/ delle sue storie…” perché la vita si era raggrumata nelle cose “gli affanni le allegrie forma confusa” e la casa stessa soffre “in silenzio…/ mentre perde i connotati”. E, come abbiamo già indicato, il paradosso salvifico sta in una sorta di “marcia indietro”, nel ritrarsi in una zona protetta, certo melanconica, ma sicuramente per Grattacaso ancora possibile: “è proprio il niente/quell’attimo di vita insospettabile, per privazione per insufficienza, che vorremmo durasse, quota zero/ che festeggiamo, lì finisce il tempo/ ed ha principio il modo che farà”.
Stefano Vitale
@@@
Note sull’Autore
GIUSEPPE GRATTACASO è nato a Salerno nel 1957 e vive a Pistoia. Ha pubblicato i libri di poesia Devozioni (1982), con una nota introduttiva di Renzo Paris, Se fosse pronto un cielo (1991), introduzione di Alessandro Parronchi, Confidenze da un luogo familiare (2010).
Con La vita dei bicchieri e delle stelle nel 2013 ha vinto il premio Pontedilegno Poesia. Il suo primo libro di racconti è Parlavano di me (2015), diventato in seguito anche testo teatrale. È autore di un blog di poesia contenuto nel sito www.giuseppegrattacaso.it. Collabora al web magazine “Succedeoggi”.
***