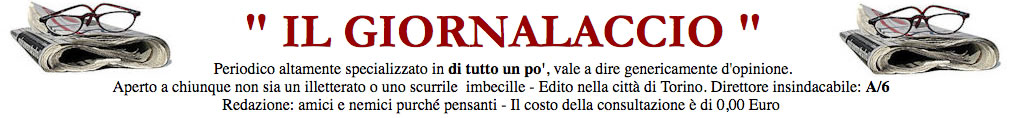“IL NATURALE DISORDINE DELLE COSE”
di Andrea Canobbio (Einaudi, 2004)
Si dice che è un giallo. L’autore vuole farlo credere ai suoi ingenui lettori, ma non li può ingannare tutti. Qualcuno ha scritto (recensioni oneste, quarti di copertina) che è un libro di impianto geometrico e perfetto, pulito e squadrato, un onore all’ingegno narrativo, ma di geometrico a me pare ci sia un’unica enorme, esclusiva metafora. Si provi a leggere il libro con la seguente equazione e cambierà completamente: architetto di giardini protagonista del romanzo = scrittore, autore del libro, e poi via di conseguenza: giardino = romanzo, progetto del giardino = struttura del romanzo. Ed ecco che il giallo svanisce, al geometria si frantuma in uno specchio infinito e ci si trova di fronte a un lungo monologo interiore. Anzi a una lunga confessione sullo scrivere. Il che potrebbe anche a tratti essere interessante, anche perché la metafora, pur non essendo originalissima, si presta a varie e istruttive divagazioni, che per altro l’autore padroneggia con una scrittura che a volte riserva piacevoli sorprese. Il guaio è trascinarla per tutto il libro, il guaio è tentare di costruirci una storia intorno, che palesemente oscilla.
A dirla con la metafora di Canobbio (e gliela rubo senza malizia, perché è lui stesso a forzarla fino a questo punto), il terreno a un certo punto non dà più frutti, perché è invaso dalle radici enormi dell’ego dell’autore, soffocato da uno sguardo sempre e assolutamente rivolto a se stesso. I personaggi non riescono a respirare, sono di carta e basta, creature funzionali a una celebrazione di sé. Da che mondo e mondo la letteratura ha giocato con se stessa, usando messaggi autoreferenziali, ma tutto sta nel trovare un equilibrio plausibile. Tutta la storia (tralasciando una complicata e volutamente difficile da seguire sequenza di eventi) è giocata su un giardino da costruire, un sogno per gli altri, uno spazio ben disegnato nel disordine del mondo (e che altro aggiungere alla definizione canobbiana, ma anche abbastanza universale, di letteratura?). Un po’ troppo facile, un po’ inutile, perché la metafora, una volta svelata, rende assolutamente vani e vaghi tutti gli artifici costruiti intorno. L’intreccio narrativo, che procede per salti temporali, con un impianto volutamente e ambiziosamente virtuosistico, a volte rischia di collassare, perché la forza centripeta dell’autore attira tutto intorno a sé, in un vortice dal quale, a un certo punto, si vorrebbe uscire.
La forza del libro è la scrittura: sicuramente dietro c’è una mano abile e sicura, che piega le immagini a similitudini a volte davvero interessanti. Ma la stessa mano non ha sempre la stessa leggerezza e rischia di perdere l’equilibrio. La schiena della donna amata che in una notte d’amore si inarca come un ramo carico di fiori è un’intuizione delicata dello sguardo del protagonista giardiniere e di uno scrittore attento alle pieghe dei significati possibili, ma l’azzardo di costruire una descrizione del proprio lavoro di romanziere dentro un giallo è la conseguenza di un’eccessiva fiducia in quell’abilità simbolica. Come non leggere in trasparenza pagine come questa: “Ci sono momenti in cui non mi dispiace lasciarmi sommergere dall’ondata delle idee, altri in cui più le idee sono brillanti e promettenti, più mi insospettiscono” (15), oppure “ogni tanto pensi di aver trovato il terreno della tua vita, non l’avevi mai visto, ma lo riconosci. […] Quando lo rivedi pieno di aspettative, il giorno dopo o anche solo un’ora dopo, non ti dice più nulla” (22), o “è un mio vezzo presentare il giardino ai proprietari prima di aver concluso le rifiniture. Era nato da un insicurezza iniziale, nei primi lavori mi riservavo di poter ancora cambiare alcuni elementi sostanziali se mi accorgevo che il cliente non era soddisfatto. Adesso la mia fama è tale che di rado i clienti osano proporre e tantomeno criticare” (171). E ancora “Un giardino lo devi pensare come un organismo che ha delle radici e le radici sono piantate altrove, nel corpo di chi l’ha pensato, e tu ne vedrai sempre solo una metà; le radici non puoi vederle, non puoi descriverle” (234). Il giardino è il romanzo e l’autore lo conferma quando costruisce per i suoi committenti un giardino complicatissimo, dai simbolismi talmente difficili che sopporta almeno tre interpretazioni, due gentilmente offerte dall’autore (la vita del committente, la vita del protagonista, che si schermisce “scuoto la testa, non credo di aver voluto raccontare qualcosa di me, almeno non consapevolmente”, 254, ma bisogna credergli, dal momento che poco prima scrive: “l’unico argomento che mi appassiona sono io”?) e una gentilmente offerta da me: il giardino che costruisce è lo schema del romanzo.
Sette sezioni, (nel romanzo sono quasi sette, cioè sei, giusto per non farla troppo facile, e ogni capitolo non ha un titolo, ma solo un numero scritto in lettere), con uno snodo importante al numero quattro (quello che l’autore definisce uno “snodo cardanico”, 174), che, a leggere bene, si riconoscerebbero senza troppe stiracchiature nell’architettura del libro. Un libro che si autodescrive e che nasce per raccontarsi. Non è troppo, davvero? No, se non ci fosse la presunzione di costruire un giallo intorno, una scusa, un teatrino che non ha altra funzione se non quella di coronare l’egocentrismo di chi scrive e che scrivendo lo confessa senza troppe ambiguità: “L’unico monumento che mi interessa è quello alle mie ossessioni, l’unica celebrazione è quella dei miei chiodi fissi, l’unica apologia è quella delle mie visioni. L’unico argomento che mi appassiona sono le idee che mi sfrecciano nel cervello” (71).
A fronte della presunzione dell’autore mi prendo la libertà di essere un po’ presuntuoso anch’io e confesso di essere un cliente che propone e critica e che soprattutto vede senza troppe difficoltà le famose radici di quel giardino, che l’architetto pensava di occultare, ma senza troppo successo. A molti, non solo scrittori, capita di essere al centro dei propri pensieri: basta nasconderlo un po’ meglio.
Artufo (il critico arcistufo)