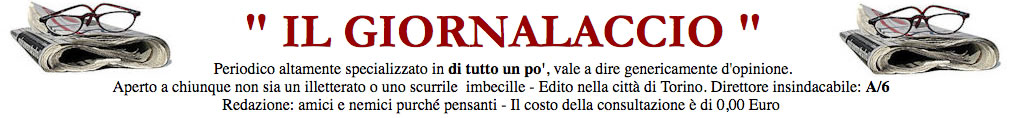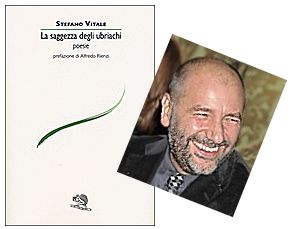 L’obliquità di questo titolo, suggestivo e provocatoriamente ossimorico, è la lente prismatica che Stefano Vitale ha usato nella poiesis di questa raccolta e che consegna al lettore perché possa accedere agli strati della realtà esplorata e narrata.
L’obliquità di questo titolo, suggestivo e provocatoriamente ossimorico, è la lente prismatica che Stefano Vitale ha usato nella poiesis di questa raccolta e che consegna al lettore perché possa accedere agli strati della realtà esplorata e narrata.
Di quale saggezza, dunque, sono portatori gli ubriachi? Chi sono costoro e perché ammiccano sulla soglia, se l’autore, come si vedrà, predilige in realtà come strumenti una lucida riflessione e una pensosa rielaborazione delle «cose che accadono»? L’indagine, infatti, viene condotta con tenacia alla “luce della ragione”, attirata e attivata dalla «percezione del reale» e sviluppata con consapevolezza a volte feroce.
Ma può succedere che questa «luce» (uno dei lemmi distintivi della raccolta) risulti insufficiente e inaffidabile: come “archeologo di se stesso”, l’io poetico si mostra costantemente intento a «preparare piani segreti/ mappe di resistenza, attraversare campi minati/ e tagliare barriere di filo spinato». Tuttavia, nell’affievolirsi “serale” del dominio logico-razionale, l’esplorazione del mondo, stanza o cielo che sia, trova nutrimenti e sostanze, forse inattese, dagli influssi più lunari di una saggezza intuitiva, dal distrarsi del controllore mentale, dall’irrompere di elementi disassati e imprevisti.
Un’ebrezza sui generis, quindi, che nell’incedere riconosce valore anche alla sosta, che affida anche all’intuizione la speranza di attraversare il «campo minato» senza deflagrazioni. Un meccanismo complementare di conoscenza, non dissimile, nell’essenza, da quello che prende le mosse, nei Moments musicaux in ultima sezione, dall’innesco musicale, dalla osmosi tra l’onda significante della parola e quella emozionale delle note.
È una esperienza feconda per il cercatore – di poesia e di vita – incontrare la parola di Stefano Vitale o rincontrarla in questa nuova raccolta, che prosegue nel solco più autentico e, in quanto tale, più sofferto quella poetica che verso a verso, passo a passo, tempo su tempo si è andata delineando nelle precedenti raccolte, in particolare: Le stagioni dell’istante (2005), La traversata della notte (2007) e Il retro delle cose (2012).
Stefano Vitale ha sempre avuto il pregio della chiarezza: non quella banalizzante o didascalica di facile arredo, ma una chiarezza caparbiamente raffinata e secreta. Ha lavorato con tensione e attenzione sull’occasione poetica, sulla materia sorvegliata del verso, del suono, della parola. Ci conduce tra specchi deformati, vapori, ombre, disegni abbozzati, alla ricerca del Vero, che per noi tutti «eterni dilettanti della vita», «fatti della stessa materia dei nostri sbagli» è il naturale senso del viaggio stesso «passo dopo passo/ all’indietro/ verso la prima e ultima luce».
La forza di questi testi sorprende sia per la grande veemenza concettuale degli incipit, sia per l’eruzione dal fondale delle riflessioni e dei pensieri introspettivi, di improvvise e decisive aperture gnomiche («la voglia di sentenze»), che nulla hanno a condividere con il facile epigrammismo e la saccente sentenziosità che inaridiscono certa poesia contemporanea. Sono, invece – esiti felici del contatto profondo tra l’autore e le sue personali verità – costellazioni per la guida ai naviganti di queste pagine, cibo da condividere, o almeno, da offrire sulla tavola di questa poetica. La fluidità del dire, la sobria eleganza dei componimenti, le calibrate assonanze e la compiutezza sintattica fanno sì che l’invito di Stefano Vitale alla lettura risulti agevole da accogliere.
Sulla via percorsa dal poeta, impegnativa e sincera fino alla nudità, ognuno può ritrovare anche una propria orma, e rileggerla con occhi rinnovati, e può essere richiamato in un qualche tempo che, dilatandosi dal personale all’universale, anch’egli avrà già vissuto.
Le soste, le ripercorrenze, le intimità con la poesia pensante di Vitale avvengono con convergenza ustoria sul senso alto e profondo della sua parola. Una verticalità ad altezza d’uomo, dove, fatalmente, la dimensione essenziale è il tempo, nominato – insieme a “giorno” e “vita” – quasi ossessivamente: «tempo andato a male», «in gabbia», «venuto qui a morire», «tempo che intanto tutto allevia».
È il tempo, infatti, un’altra potente esperienza collettiva – almeno nella radice occidentale – in cui si viene coinvolti da La saggezza degli ubriachi. Per l’autore il tempo è vessillo, veste e sudario, già esibito ne Le stagioni dell’istante e ne La traversata della notte e qui si fa potentato e padrone della vita. Il tempo della saggezza e dell’ebrezza, quello musicale della parola e quello variante e sospeso della musica, segnano ogni pagina di questa opera matura e solida.
La voce narrante suona con la metrica dell’individuo, ma riecheggia con la larghezza dell’esperienza universalmente umana, tenace e fragile, di noi «figli di un destino comune», «inermi creature/ sedute sull’orlo di un cielo in tempesta».
La consonanza si rinsalda ancor più perché nell’invarianza del «nostro Esserci» Stefano Vitale sa privilegiare la contemporaneità, non tanto degli scenari, il più delle volte interiori e poco oggettivati, quanto del tono. Il dubbio, il disorientamento vanno a evocare le categorie bigie del timore dell’errore, del disincanto sfiduciato, della preoccupazione per il nostro apparire e per l’essere controfigure di noi stessi. Talora si espande – come dichiara il titolo di una sezione – un clima da guerra civile, interiore e metonimica. La resa pittorica di queste tonalità è segnata dal gioco di ombre, di una luce, anelata ma non casualmente spesso «assente», «sempre più scura», «poca», «ultima», «residua».
Dato quest’ordito di fondo, viene facile, inoltre, sorprendersi per le aperture della sezione Dal terrazzo, quasi un controcanto più luminoso lanciato oltre le strettoie del tempo, una vera e propria finestra su un altro codice del reale. Anche qui Vitale non smentisce la sua incessante e necessitante indagine, al punto che lo stupore per il «trionfo innocente dell’allegrezza/ di questa inquieta primavera» non può che essere, una volta colto, rielaborato nell’interiora terrae e richiamare, con le luci della sera, l’«intima necessità dello svanire».
Accade così, anche nelle epifanie dal terrazzo o nelle suggestioni di Moments musicaux, che l’autore, nel sacrosanto areale del dubbio inemendabile, cercando il Vero e duellando con il tempo che stritola e coercisce, dica: «scriviamo parole invisibili/ su una lavagna trasparente». Il lettore si accorgerà, per contro, di quanto rumore e sostanza questi versi sappiano produrre e come possano «Tirar fuori dalla selva del tempo/ una parola certa e precisa/ […] per dare un senso/ al silenzioso scrutarsi delle cose». E si capirà bene, da ubriachi saggi, che è proprio questa continua e infaticabile ricerca di senso «l’incrollabile speranza/ che porta al fine di ogni arte».
Alfredo Rienzi