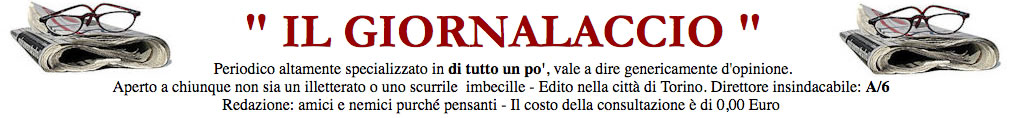Elizabeth Strout: mi chiamo Lucy Barton
Einaudi, Torino
 Elizabeth Strout è nata nel Maine ma da anni vive a New York. Soprattutto è una scrittrice famosa che ha vinto il prestigioso Premio Pulizer (2009) e anche il Premio Bancarella (2010) e il Premio Mondello (2012). Dalla sua serie di racconti riuniti nel libro “Olive Kitteridge” è stata tratta una nota serie tv, prodotta dalla Hbo. Un transatlantico della letteratura contemporanea, dunque. Il suo ultimo romanzo viene pubblicato da Einaudi e non più da Fazi come i precedenti e promosso in questi giorni con un battage giornalistico e mediatico degno di una star. La traduzione è di Susanna Basso, la grande traduttrice di altri grandi autori anglosassoni.
Elizabeth Strout è nata nel Maine ma da anni vive a New York. Soprattutto è una scrittrice famosa che ha vinto il prestigioso Premio Pulizer (2009) e anche il Premio Bancarella (2010) e il Premio Mondello (2012). Dalla sua serie di racconti riuniti nel libro “Olive Kitteridge” è stata tratta una nota serie tv, prodotta dalla Hbo. Un transatlantico della letteratura contemporanea, dunque. Il suo ultimo romanzo viene pubblicato da Einaudi e non più da Fazi come i precedenti e promosso in questi giorni con un battage giornalistico e mediatico degno di una star. La traduzione è di Susanna Basso, la grande traduttrice di altri grandi autori anglosassoni.
La storia di Lucy Barton è narrata al passato e racconta di eventi già risolti, e questo ci dà subito un gran sollievo. La protagonista è una futura scrittrice di fama, nella quale non si fa fatica ad intravedere l’autrice, che si trova in ospedale per un lungo periodo. Dalla sua finestra d’ospedale si vedono le luci del grattacielo Chrysler, emblema delle aspirazioni nella Grande Mela degli anni Ottanta, come ci ricorda la terza di copertina.
Arriva quasi improvvisamente la madre dell’inferma con la quale lei ingaggia un dialogo che durerà cinque giorni, tanto dura la visita materna. E’ l’occasione per parlare del passato, per sentirsi accudita da una madre spesso distante, per ricordare persone oramai scomparse, rivivere brandelli di infanzia e di vita familiare che si rincorrono nel testo con un certo ricercato ordine logico.
La protagonista ripercorre la sua vicenda familiare nella provincia dell’Illinois, il suo desiderio di fuga, il fratello un po’ gay un po’ matto, la morte dell’amico malato di Aids, il padre roso dal senso di colpa per aver ucciso in guerra, sparandogli alle spalle, due giovanissimi tedeschi in borghese. Ma Lucy-Elizabeth non ci risparmia ovviamente la sua vicenda familiare adulta: il matrimonio, le due figlie, la separazione, il nuovo marito e la sua crescita come scrittrice. Insomma tante cose accadono in questo romanzo di 160 pagine scarse. Un flusso continuo , monotono, sempre uguale di fatti e avvenimenti raccontati col tono rassicurante dell’amica che sta passando il pomeriggio a casa tua sorseggiando un thè.
La sua prosa è imbevuta di gergo “giornalistico” rosa pallido, esprimendo un sound che non deve arrecare disturbo al lettore. Una musica di sottofondo che è noiosa se ci fermiamo ad ascoltarla, commestibile se passiamo oltre. Strout lo sa e tira dritto, scivolando con la sua plancia da surf sui sentimenti umani ormai deprivati da ogni autentica emozione. Ogni singolo avvenimento narrato, ogni soggettività che viene solo sfiorata, si disperde nel linguaggio comune dell’informazione e nulla lascia emergere segnali di esemplarità nel racconto.
Strout ci lascia liberi di immaginare quel che ci pare, ma non perché il suo narrare sia evocativo, magico, potente, bensì perché tutto resta sul piano superficiale della storiella appena abbozzata, sfiorata, al limite dell’aneddoto. Così ci dobbiamo stupire dinnanzi alla paura preliminare del dentista, al calore della mano rassicurante del padre dietro la nuca, ai tremori del fratello, ai litigi sotterranei col marito, ai silenzi della madre.
Intimismo è la parola d’ordine. Non che sia un male in sé, tutt’altro. Ma il tono certamente antiretorico del testo sconfina troppo spesso con il ronzio irritante di una zanzara noiosa e appiccicosa. L’autrice non ci risparmia riflessioni “folgoranti” con grandi massime quali “nessuno arriva dal nulla” (pag. 126) o “come facciamo a garantire che non ci sentiamo inferiori ad altri?” (pag. 67). Il climax rivelatore è a pagina 90: “…quel che ha scritto è davvero bellissimo, glielo pubblicheranno… è la storia di una madre che ama sua figlia. In modo imperfetto. Perché tutti amiamo in modo imperfetto”. Così possiamo tirare un sospiro di sollievo. Ed Elizabeth Strout darci anche lezioni di scrittura dicendo che “mi piacciono gli scrittori ch si sforzano di raccontare qualcosa di vero” (pag. 39) come in una sorta di manifesto programmatico; e che “ciascuno ha soltanto una storia. Scriverete la vostra unica storia in modi diversi. Ma tanto ne avete una sola” (pag. 122).
Strout ci vuole a tutti i costi raccontare questa sua storia, che però è qualcosa che non ci arriva, che resta lontano, dispersa nella cronaca, senza ambasce, angosce, ma anche senza arguzia o allegria. Lei scrive in modo lineare, corretto, senza intoppi. Niente di più. Lo stile è quello del “ron ron” letterario che fa le fusa e se ne va senza lasciare traccia e che tanto piace perché ricorda le lunghe telefonate con le amiche.
Nessuna ironia, nessun sussulto critico ed etico vero (certo alla fine si parla anche dei soldi “nazisti” ereditati dall’ex marito che la protagonista rifiuta): la scrittura deve scorrere e non dare fastidio, giusto un po’ di noia, ma rassicurante come una pietanza cucinata senza idee né slanci, ma che mangiamo da sempre. D’altra parte la Strout-Burton ci rivela che non sa cucinare.
Insomma se ci aspettiamo una prova letteraria che si connetta in qualche modo ad una tradizione umanistica per la quale la letteratura ha una forza conoscitiva, abbiamo sbagliato indirizzo. Non ci interessa che Strout scriva come Tolstoj, come Musil e neppure come Philip Roth o Julian Barnes. Ci basta anche meno, ma la “verità” cercata nel suo narrare si dissolve nel momento in cui i fatti accadono senza un reale filtro linguistico che ci faccia pensare.
La letteratura dovrebbe reinventare il mondo, qui la scrittura annaspa, inciampa e si sdraia nel comodo divano newyorkese di una ricca signora venuta dalla provincia che ha così realizzato il suo sogno, il suo businnes sentimentale. Non c’è necessità di approfondire: raccontare in prima persona non è la chiave per aprire mondi che ci sorprendono, ma solo la scorciatoia per l’ovvio. Sembra di leggere lo story board di una fiction televisiva, non un romanzo. Tutto resta a metà, anzi non inizia mai veramente.
Solo nelle ultime pagine dobbiamo rilevare un cambio di tono e di passo. Le ultime tre pagine sono sincere, anche toccanti nella loro essenzialità emotiva meno scontata. La frase finale è ad effetto, ma niente male (“la vita mi lascia sempre senza fiato”). Basta pensare non
l’abbia detto al termine di una conversazione telefonica di ore con la sua migliore amica. Davvero troppo poco. Ma il frastuono è tanto.
Alterez
Maggio 2016