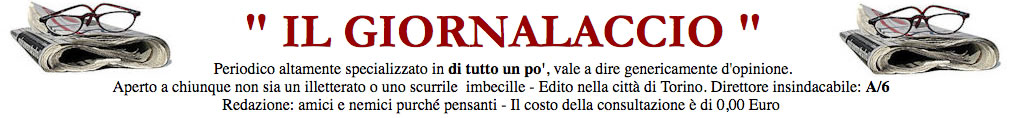La scuola cattolica raccontata in lungo e in largo

“La scuola cattolica” di Edoardo Albinati è l’opera vincitrice del Premio Strega 2016. Vorrei che fosse chiara una cosa: noi non sconsigliamo i libri che vincono dei premi per partito preso, ma perché ci prendiamo la briga di leggerli, per davvero. Poi che si dia una valutazione diversa è una cosa ancora lecita.
La giuria dello Strega torna a premiare un’opera pubblicata da Rizzoli, ma credo abbia avuto in mente, più che la letterarietà (vera o presunta) del libro, la sua commerciabilità. E in ogni caso il battage pubblicitario e mediatico precedente ha sempre la sua funzione. Non a caso il premio è da sempre nell’occhio del ciclone.
Certo questo è un libro molto pesante, 1294 pagine, e da questo punto di vista potrebbe essere poco vendibile, poco digeribile. Ma forse qui sta l’originalità dell’impresa aziendale: riuscire a convincere il pubblico che si può comprare un libro anche così grosso e spesso e poi metterlo in libreria. Tanto quel che conta non è leggerlo, ma dire che ce l’hai o far finta che l’hai letto.
Noi, come detto, lo abbiamo letto. Ci abbiamo messo tutta l’estate. Ma abbiamo capito che più che un romanzo La scuola cattolica di Albinati è una mastodontica, logorroica dissertazione personale sugli anni ’70 e sul declino della borghesia, sul rapporto tra uomini e donne e sulle implicazioni della violenza. Lo strombazzato Delitto del Circeo è poco più che un pretesto per parlare di altro, o di tutto. O di niente.
L’autore stesso è consapevole dell’ipertrofia del suo testo e ammette in un capitolo che suona come ‘excusatio non petita’: «L’ho presa un bel po’ alla larga? Avete ragione: ma era la natura stessa del delitto a richiedere che se ne raccontassero i preliminari; o piuttosto, i cerchi concentrici che lo avvolgono, gli anelli che da un lato vi conducono, dall’altro se ne allontanano, come in certe insegne luminose. La scuola, i preti, i maschi, il quartiere, le famiglie, la politica. Potrebbe darsi che al centro del bersaglio non vi sia alla fine quel delitto, ma qualcos’altro…» (p. 252). Il concetto viene poi ribadito: «Questa storia ne comprende altre. È inevitabile. Si ramifica o è già ramificata al momento in cui si apre. Si sovrappone come succede alla vita delle persone. […] Quindi in questo libro la storia principale quasi non si vede» (p. 1068).
Il delitto del Circeo (DdC come lo denomina Albinati) è messo lì in mezzo al libro, come una zattera malandata in mezzo ad un oceano. Forse serviva ad attirare il pubblico sempre assetato di sangue. Oppure l’autore vuole dirci che quell’episodio, così crudele e duro, è in realtà il frutto di una mentalità, di una cultura di quegli anni violenti e rispetto al quale la stessa Chiesa Cattolica, coi suoi precetti, la sua forma mentis educativa, ha delle responsabilità. Forse.
Resta il fatto che abbiamo anche capito che questo libro Albinati lo ha scritto nell’arco di un quarantennio (1975-2015), dunque l’ha scritto per accumulo. Lo stesso narratore protagonista del testo, che più volte lascia intendere essere lo stesso scrittore, è indirettamente implicato nel ‘Delitto del Circeo’ per aver frequentato la stessa scuola cattolica dei giovani che sequestrarono due ragazze – delle quali una non sopravvisse alle sevizie. Ma questa parte dedicata al DdC è piccolissima al confronto del resto. Che è pesantissimo.
Albinati ci sequestra con le sue digressioni sul proprio percorso formativo, che è poi quello di una generazione, forse. E che assomiglia a quello dei suoi personaggi. Anche a quello di quei criminali la cui estrazione era appunto borghese. Quello era un tempo in cui questa classe sociale perdeva la sua identità (Pasolini, lo aveva capito bene e Albinati gioca a fare il Pasolini quarant’anni dopo) , anni in cui la politica era permeata di violenza e la società era attraversata dalla progressiva emancipazione delle donne.
Albinati allora ci ipnotizza sino alla noia con le sue considerazioni su questi temi. Specialmente ci costringe a leggere delle imprese, e non imprese, di adolescenti frustrati, ossessionati dal sesso immaginato e mancato; ci conduce attraverso una galleria di insegnanti depravati, più o meno apertamente, condizionati da una morale repressiva, repressa e reprimente.
Albinati ci descrive, usando il lessico giusto e il gergo appropriato del tempo, le intimità frustrate e deliranti di giovani ragazzi alla ricerca di una identità sessuale e sociale. Sinceramente tutto molto noioso e scontato. Forse anche fuori tempo. Una roba da reduci delle scuole cattoliche, degli oratori. Certo potrebbe sembrare la rivelazione di una realtà nascosta. Ma sinceramente non stupisce più nessuno, specie di questi tempi.
Ma non basta. Albinati è convinto che il suo racconto possa e debba comprendere anche degli insegnamenti. E allora ci dice la sua verità sull’essere maschio: «Il profondo e naturale bisogno dei maschi di ottenere amore e tenerezza e calore da parte degli altri maschi rimane quasi sempre insoddisfatto ed è per questo che viene interamente (e talvolta brutalmente) girato sulle donne» (p. 44). Oppure sulla crudeltà: «[…] la debolezza eccita una crudeltà che altrimenti non esisterebbe» (pp. 404-405). E ovviamente sulla violenza: «Attaccando insieme una donna, i maschi si sottraggono almeno temporaneamente alla violenza reciproca» (p. 773); e anche: «A chi ci provoca un dolore, siamo immensamente grati se cessa di farlo. La nostra riconoscenza finisce quindi per essere rivolta verso chi ci ha fatto del male. Questo spiega perché alcune donne restino legate a mariti o amanti che ne abusano: sono i momenti di tregua ad avvincerle con un nodo più serrato» (p. 1065).
Insomma il lettore è costretto a viaggiare disperatamente in un labirinto claustrofobico di situazioni, sentenze, episodi per lo più inessenziali e noiose, lo ripeto. Ore ed ore di lettura sprecate nel tedio di queste elucubrazioni tardive. A me pare una specie di abuso. Forse che Albinati volesse con questo costruire una enorme metafora del tempo adolescenziale? Per lo meno della sua esperienza? Il problema non è la lunghezza: è l’inutilità di tale lunghezza. Abbiamo adorato romanzi lunghissimi, non solo dei classici, ma erano “Romanzi”.
E la scrittura? Almeno quella funzione? In una sorta di iper-realismo biografico, Albinati si attarda in una scrittura ordinaria, ordinata e senza fantasia, magari anche corretta, ma sempre incapace di dare un senso, una direzione al racconto. Che infatti non c’è. Il tono è didascalisco, volutamente piatto.
Dire che questo è un romanzo è come dire che la Cremonese è una squadra costruita per vincere la Champions; che mio cugino idraulico è un architetto. ‘La scuola cattolica’ non è un romanzo: sincerante non ho capito ancora che cosa sia. Lo si chiama romanzo solo nella misura in cui questa denominazione si è talmente svuotata di senso al punto da accogliere ogni forma scritta in cui vi sia una minima traccia pseudo-narrativa.
Albinati ha scritto un libro che ha vinto il più ambito premio letterario italiano, ma che è tutto tranne che un romanzo: un libro che segna una mutazione genetica di cui occorre rendersi conto. D’ora in avanti possiamo definire “romanzo” uno sguazzo di notazioni psicologiche e sociologiche che devono riempire le pagine di carta di un oggetto detto “libro”, ma lasciare il tempo che trovano. Anche la trama non è importante: qui poi è scarna e confusionaria. Anzi così è meglio perché sembra più “complicato”, più studiato.
Ma se non è un romanzo, è forse allora un saggio? Neppure. Chi è abituato a leggere saggi, filosofici o giù di lì, sa bene che certe cose vanno dette e soprattutto scritte con cognizione di causa. Albinati trasforma le sue esperienze in verità assolute, ma Albinati non è un filosofo e neppure un sociologo e nemmeno uno psicologo. Manca pure la bibliografia. Nella nota finale, infatti, avverte di aver attinto a piene mani qua e là. Albinati è indubbiamente sic et simpliciter uno scrittore, magari anche bravo. Lo si vede quando narra in quei pochi sprazzi del libro. Se rivedesse, allora, il libro, sforbiciando e riscrivendolo, sarebbe una buona cosa. Per riportare il libro a romanzo, a opera letteraria. Si sforzi allora l’Autore a farci vedere pure i problemi, ma evocandoli attraverso la narrazione e attraverso la costruzione dei caratteri dei personaggi. Più narrazione e meno chiacchiere, dunque.
L’unica parte che ho trovato accettabile è quella del capitolo intitolato “Cosmo”. Una serie di aforismi scritti nello stile classico del genere che si può leggere come una parte a sé. Scritti con acume e proprietà di linguaggio, senso etico e dolente pessimismo. Ma soprattutto sono brevi. Una specie di condensato efficace del senso ultimo di questo libro incredibile che senza dubbio potete evitare di leggere, anche perché rende nervosi e questo può essere negativo per la salute. Oppure ve lo leggete, vi fate un po’ del male, ma almeno vi siete vaccinati.
Alterez
Ottobre 2016