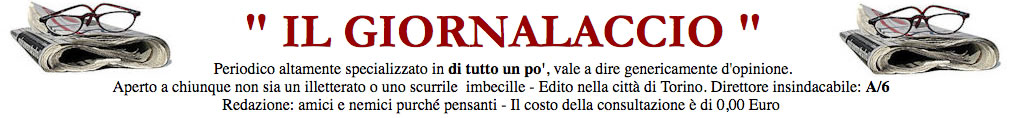Un bene al mondo di Andrea Bajani
(Einaudi, 2016)

La narrazione della condizione dell’infanzia non è cosa semplice.
Si rischia il sentimentalismo: in questo racconto ci siamo dentro come nelle sabbie mobili. Affrontare il tema dell’infanzia e del dolore che si prova nell’infanzia significa descrivere l’assurdità di situazioni che spesso gli adulti hanno determinato e dalle quali fuggono: qui l’assurdo è il racconto stesso. Ma non perché sappia farci incontrare con consapevole maestria il male di esistere, ma perché è un racconto che ti fa davvero vivere male, specie se lo leggi.
Questo racconto di Andrea Bajani è irritante per a sua vuotezza e la sua presunzione. Assecondata, ovviamente, da molti critici compiacenti. Il racconto avrebbe la pretesa di metterci di fronte alla nostra stessa essenza umana, impastata di gioia e di dolore, condizionata dalle tristezze familiari, arrostita sulla griglia delle quotidianità grigia e normale. Il racconto ha la pretesa della “fiaba nera”, di una narrazione sapienziale, un romanzo di formazione universale in formato pocket che ci dovrebbe accompagnare in una buia caverna: quella del nostro dolore, del doloroso passaggio alla vita adulta.
Ma questo testo offre, alla fine, molto, molto meno di quel che promette. Di questa faccenda della “comprensione” di una nuova innovativa perché antica e radicata “cognizione” del dolore non vi è alcuna traccia. Solo una presuntuosa gitarella tra giadinetti letterari, come in un vuoto teatro di posa dove tutto è abbozzato, accennato, insomma cartonato. Il “non dire” dovrebbe avere la funzione di indicare qualcosa di grande, di nascosto. Purtroppo mette in luce solo il nulla narrativo di questo libro. Il dolore del bambino che lo accompagna come un cagnolino, sembra ed è una filastrocca, è una figurina del pensiero dello scrittore che gonfia la vela di un raccontino fragile ed esile, ma senza profondità. Altro che “forza della letteratura”. Il libro lascia disorientati non perché ci spinga ad esplorare con l’energia della parola un mondo sotterraneo, ma perché la disaggregazione narrativa raggiunge un punto di presunzione tale che della narrazione non resta più nulla. Solo frasette sentenziose, rarefatte certamente, leggere come il nulla. Si vede che questa deve essere una prerogativa di certa letteratura moderna.
Gli elementi della storia – personaggi, ambienti, cronologia – sono come disossati, ma ciò non porta ad un essenziale drammatico, bensì ad un girare a vuoto che dopo dieci pagine irrita per la ripetitività, la noiosa supponenza. Non c’è elevazione, come qualcuno ha strombazzato per favorire la diffusione del prodotto: c’è giusto posto per l’indistinto, l’anonimato narrativo. Certo voluto venduto come forma del sacro: in effetti solo un quaderno di appunti disassati, disastrati.
Dire che “il disorientamento si fa trama, diventa cioè una procedura narrativa che consiste nel combinare gli elementi del racconto riconfigurandoli, appunto, per la via dell’assurdo” è solo nebbia critica buona per nascondere dietro ad una presunta misteriosità, la riduzione del racconto ad un prodotto di basso consumo. Ogni riferimento a scrittori come Calvino e Tabucchi suona davvero blasfemo. Ma c’è chi ha avuto il coraggio di farlo. Nessun legame tra questo “Un bene al mondo” e “ Se una notte d’inverno un viaggiatore”. Se c’è un contatto è nel fatto che se Calvino avesse letto questa storia di Bajani si sarebbe ancora più affrettato a immaginare, come fa nel romanzo citato, un mondo cancellato, pezzo dopo pezzo pur di veder sparire Bajani.
I temi del dolore e dell’assenza, fisica o emotiva, il sentimento della lacerazione generazionale sono centrali nei suoi romanzi maturi (Se consideri le colpe, 2007; Ogni promessa, 2010) e qualche cosa di buono avevano detto. Qui alcuni temi ritornano in chiave estraniata, stranita, ma banale, purtroppo. Nell’introduzione al volume dei Racconti di John Cheever, Bajani ha osservato che scrivere significa «dare udienza ai fantasmi»: in questo suo racconto, il fantasma è la letteratura.
Non è un problema che non vi sia una storia. In effetti qualcosa c’è. Il tremendo è farci credere che ci sia un senso urgente in questo suo narrare una storia che non c’è. Non c’è neppure la possibilità di leggere il racconto come un flusso di coscienza: è solo uno scorrere di frasi fatte, scontate e prevedibili. Non è un problema la fiction: non è obbligatoria, ma qui la finzione è proprio quasi una fregatura. Ti aspetti che la scrittura possa porre delle domande (noi non vogliamo facili risposte) e Bajani ti accontenta: ti offre delle soluzioni. La presunta allegoria della vita segnata dal confronto col dolore, che è poi il dolore dei padri, che è poi il dolore imposto ai figli dalle ferite degli adulti, un dolore senza scampo, col quale convivere per sempre è risolta in una struttura narrativa prevedibile, senza colpi d’ala. Tutto già visto.
La poesia è scimmiottata dal gioco della punteggiatura. Andare sempre a capo, fare frasi brevi contrassegnate da un punto: questa la poesia di Bajani. Un nutrimento stilistico che non si ciba certamente dell’esempio del grande Francesco Biamonti, ma si limita a seguire modi giornalistici, quelli degli articolisti “di coloratura”. Il suo preferito è il grigio smorto. Il riferimento a Leopardi nel titolo e la citazione iniziale di Herbert sono solo una cornicetta, quasi uno specchietto letterario: dentro e dietro non vi si trova quasi niente.
Il «bambino» di “Un bene al mondo” alleva «un dolore da cui non voleva mai separarsi» e che il narratore rappresenta come un animale domestico: quasi un cane fedele, che accompagna e consola il protagonista dagli assalti del violento dolore paterno e dallo sguardo vuoto di una madre che ha perso il proprio di dolore ed è perciò incapace di emozioni. Il dolore del bambino, più che sofferenza, è assenza di colore, riparo dentro «il cubo dell’infanzia», «il dado della commozione» (così nei versi di La casa di Zbigniew Herbert, citati in epigrafe). È la forma totemica assunta dal sentimento disforico in cui il bambino si sdoppia e attraverso cui si completa. Nel perimetro in cui vivono i personaggi senza nome di Bajani, il tempo non si svolge ma si accumula: «Il tempo era soltanto una ripetizione di gesti». E così è il ritmo del romanzo: stucchevole ripetitività da salotto piccolo borghese, si diceva una volta.
Questo stato si esprime attraverso una scrittura che tende a farsi rituale per mezzo di accorgimenti formali, come la segmentazione in brevi paragrafi, e stilistici, come l’uso ostinato dell’imperfetto che imprigiona e isola il personaggio in un tempo abitudinario, ripetitivo: «I bambini della panchina, quando diventavano grandi, non chiamavano più. (…) Il dolore seguiva il bambino senza voltarsi, perché i bambini della panchina, quando diventavano grandi, si disinteressavano anche di lui».
Ma a un certo punto il narratore fa finta di sorprenderci e, imitando l’andamento di una fiaba subito smentita, ci svela che il bambino non è più un «bambino, ma un uomo alto un metro e novanta». A guarire il «tempo ammalato», in cui sono rimasti bloccati il paese dell’infanzia, i genitori e la stessa immagine di sé che il figlio ha lasciato loro, è stata la distanza, resa possibile innanzitutto dal dialogo con «la bambina», dalle parole che il bambino le rivolge e le scrive: «Soltanto dentro quelle lettere non spedite il bambino riusciva a scappare. Dentro le lettere prendeva il dolore del padre, lo colpiva sulla testa per farsi obbedire».Ma non basta: «Gli scrisse che sua madre aveva preso un’auto nuova e che era stata lei a scegliere il colore. (…) Gli scrisse che si era comprata uno zainetto rosso uguale al suo. (…) Non gli scrisse che si sentiva sola».
Il libro è di fatto un mantra allucinatorio che utilizza tutti i topoi più frusti del genere simbolico-affettivo di basso costo. Il paese piccolo, il bar, la scuola, la stazione, i lavori e la vita di ogni giorno, e poi le figure diafane del padre e della madre, i bambini cattivi seduti sulle panchine, gli adulti indifferenti coi loro dolori inseparabili. Sono simboli il bosco, la ferrovia, il cimitero, il passaggio a livello che divide in due la città. Oltre quel limite, c’è il luogo misterioso dove vive un altro oggetto simbolico, l’oggetto d’amore idealizzato. Ma di cui non si ha né traccia, né vero desiderio.
Tutto è solo indicato, mai sviluppato altrimenti si dovrebbe davvero fare un corpo a copro con la lingua. E questa è l’ultima delle sfide che interessano Bajani, orami preso dl suo ruolo di narratore pubblico da Salone del Libro. Tutto viene risucchiato nel macinino del narratore artisticamente ripiegato su se stesso. Ad un certo punto scivola nello psicanalitico pop: la crescita dell’individuo dovrebbe culminare in un rapporto autentico con la realtà, man mano che l’Io si sviluppa. A patto però che nella fase arcaica dello sviluppo mentale una “madre sufficientemente buona”, attraverso il codice dell’accudimento, abbia posto il neonato nelle condizioni di abbracciare il simbolo.
Melanie Klein, psicanalista dell’età evolutiva, spiegando che solo la raggiunta capacità di simbolizzare il mondo in fantasmi (oggetti parziali buoni e oggetti parziali cattivi come ad esempio il dolore e la perdita, la nostalgia, l’amore, la morte, i membri della famiglia) permette di sopportare l’angoscia primaria: quella di aver perduto lo stato fusionale della vita intrauterina. Ma di questa pretesa, di questo passaggio, nel libro, non c’è traccia. Solo fumosi annunci critici, quarte di copertine agguerrite, risvolti magici e unti da sottili digressioni che si dissolvono nel testo. No, non c’è magia nel testo: solo una “abilità” costruttiva nel confezionare un brandello di letteratura di cui nessuno si ricorderà. Magari buona per impressionare le commesse o le pettinatici, per far commuovere i meccanici e gli autisti dei bus, per scalare qualche classifica natalizia (la tempistica conta), ma totalmente indigeribile per chi si accontenta di leggere un buon libro. Il ritmo lessicale, fondato su frasi brevi, ossessivamente piatte, che sempre ritornano sui propri passi; il frasario basico fatto di concetti semplici; la mancanza di evoluzione narrativa fanno del testo un perfetto “libro per tutti”.
ll libro Bajani, torniamo al poeticismo leopardiano, avrebbe il coraggio di sostare proprio in quello stato d’animo che secondo Leopardi costituiva forse l’unico Bene al mondo: l’illusione. Il guaio è che non si è accorto che questo libro ha l’illusione di essere un libro. E’ solo un aggregato di carta stretto dentro ad una copertina dai tenui colori che lo fanno sembrare un libro, ma forse è una scatola di un gioco da tavolo con qualche pedina piatta. Non c’è alcuna invenzione mitologia dell’infanzia, c’è la mitologia demiurgica di un autore che sente investito da un missione: risolvere col libro le sue nevrosi. Se ne ha. Oppure presuppone che gli altri abbiano quelle nevrosi e lui sa come spiegarle con la storia de bambino e del suo cagnolino. Il dolore è un mistero, certo, ma Bajani lo dice: la colpa è dei grandi e dei bambini che ci credono. Giusto! Ma poi che si fa? Non va da nessuna parte. Il paese dove stava il bambino coi genitori non stava da nessuna parte, non era nella vale che scendeva dalle montagne, ovviamene, più alte e non era nella valle che portava al confine… Non se ne esce, eppure tutti vanno via. Resta il dolore. D’accordo e allora?
Il protagonista , esile e sfumato del racconto, è un eroe silenzioso, dicono, che non vuole masochisticamente separarsi dal suo dolore che gli permetterà di cogliere anche momenti felici. Mi sembra di sentire parlare un neo Papa-laico che ci invita ad accettare il destino stabilito dall’anima divina, in cui ogni utopia dell’essere altro da sé viene schiacciata nel teorema di Bajani. Altrettanto si deve diffidare della chiesa: il prete potrebbe rubargli il dolore per usarlo come cavia. L’unica impresa utile sembra essere quella di crescere senza somigliare al padre e il bambino sarà diverso: non romperà i bicchieri, i piatti, non creerà famiglie vuote, forse diverrà un eremita… Così quel dolore originario e coltivato diventerà forma e nuova potenza che gli permetterà di non aver para del prendersi cura degli altri. Insomma se hai paura diventi te stesso e magari anche sereno e altruista, normale e meno psicotico. Ora il bambino imparerà a prendersi cura del dolore, con fatica e con costanza.
Il fatto letterariamente doloroso è che tutto questo è detto quasi così, con la piattezza e spudorata pretesa di saggezza. Il racconto è una giostrina dove i personaggi sono freddi, fissati ad un destino imposto dal decoro della storiella e malgrado le apparenze stagnano. Altro che “Castello dei destini incrociati” di Calvino. Qui la speranze dell’autore è che qualcuno abbia voglia di prestare “baricchicamente” la voce in un lettura fascinosa buona per farci dormire una sera al caldo.
Davvero imbarazzante la discrepanza tra il tema annunciato e la realizzazione materiale del testo. Una disprova d’autore, un inciampo che vende, specie sotto Natale, quando tutti siamo più buoni e vogliamo stupire con un testo solo apparentemente non allineato. Invece è il più melenso ed allineato di tutti. Primum vendere deinde cogitare.
“Un bene al mondo” si legge in 40 minuti, più velocemente de “La Scuola Cattolica”, ma lascia un vuoto senza fine. Non compratelo, mi sembrano soldi e tempo sprecato. Se poi lo farete, leggetelo e scoprirete l’ebbrezza di entrare e uscire, salire e scendere, andare e venire in un luogo senza forma se non quella dello zainetto rosso (clone del vestitino rosso di Schindler List) che teneramente vi riporterà a casa. Per chiudere il libro in cassetto. Per sempre.
Alterez
Novembre 2016