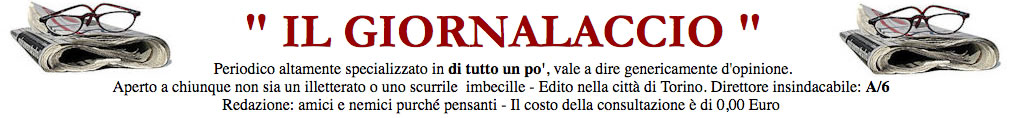Valentino Zeichen
Valentino Zeichen
LA SUMERA
Narrativa
Fazi Editore
La Sumera di Valentino Zaichen
La copertina è molto bella: una Triumph Herald, una spiaggia, una donna bruna con un prendisole adagiata sul cofano. Il racconto è già iniziato con questa copertina che ci ricorda i film degli anni sessanta. Ma raccontare questo romanzo non è cosa facile, perché siamo al di fuori dei canoni del consumo cui ci hanno abituato pletore di autori spinti dal mercato editoriale, alle prese con la sua crisi globale. Zeichen è fuori da tutto questo ed il piano su cui egli colloca il suo racconto e lo stile del suo narrare è inattuale.
Già la storia non è una vera storia, nulla che fluisca tra i binari usuali e usurati del romanzo fiction o del romanzo giornalistico. “La sumera” è un flash di vite intrecciate, colte in un momento specifico, ricco di tutta la forza e l’inutilità della vita stessa. Il libro racconta delle vicende di tre uomini (Mario, Ivo e Paolo), tre falliti che ruotano attorno al mondo dell’arte contemporanea, tre uomini annoiati che cercano nelle donne, nell’abbordare le donne, di preferenza incontrate nelle gallerie d’arte, un sussulto di vita.
Il perimetro del loro vagare è delimitato tra via Flaminia e dintorni, Piazzale delle Belle Arti, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, viale Tiziano, Valle Giulia. Sempre ritornano i luoghi, in un girare a vuoto sempre sui propri passi, metafora drammatica di un fallimento e di una ricerca impossibile di futuro. Non c’è storia, dicevo, ma un “fermo immagine”, uno scatto su un mondo interiore ed esteriore che si disfa nel momento in cui appare.
Ma chi è “la sumera”? Nel racconto non ha nome. E’ una Lei indefinita se non dalla sua bellezza orientale, dai suoi tratti marcati e dalla sua sensualità che attrae irresistibilmente i tre uomini: Ivo entra in Galleria, guarda i quadri, nota una ragazza, i capelli castani ad incorniciarne il profilo, osservandola gli sembra che “i profili sembrano ricopiati geneticamente da una madre votata a fisionomie sumere…. Lo colpirono i rilievi: aveva un grande naso dritto, carnoso, con un profilo quasi ad angolo retto, piano sul setto, e narici come due piccole bocche di fuoco, gli zigomi alti, gli occhi verdi tinteggiati ad acquarello…mostrava la carnagione di un verde tenue paragonabile a una mela golden sbiadita, gli zigomi punteggiati di lentiggini”.
Nel corso del racconto, la donna entrerà nel gioco amoroso dei tre, sia carnalmente che intellettualmente, restando sempre indefinita e padrona di sé lontana dai cliché narrativi del presente. E il finale ci riserverà anche un dramma, di fronte al quale tutti resteranno comunque indifferenti. Neppure la morte ci fa più impressione.
Ho una mia idea: la sumera è anche una scrittura antichissima di cui non si conosce esattamente il codice. Forse l’indeterminatezza del personaggio, di cui conosceremo solo la parte erotica e che resterà senza nome, rappresenta l’arte stessa, una dimensione incommensurabile, non riducibile al mercato e neppure ai tentativi degli artisti stessi che, irrimediabilmente falliscono, non riuscendo ad afferrarla mai completamente.
Poeta, e quindi grande padrone della metafora, Zeichen ci ha dato una sua meta-metafora dell’arte? Sta di fatto che il testo ha un suo impulso etico che si materializza nella critica serrata del mondo del mercato dell’arte, dei riti inutili dei vernissage, degli apertivi e buffet, dei giochi di sotto-potere dei critici che sono degli “strani individui” che “possono elevare un artista alle alte quotazioni del mercato, ma possono anche inumidire le polveri da sparo, e quello non sale più in orbita”.
Il sarcasmo tagliente di Zeichen fa il paio con la sua endemica forza epigrammatica dando definizioni e creando immagini sempre molto efficaci. L’autore è un fustigatore coinvolto dei costumi annoiati del nostro tempo, di un’idea dell’arte che non si stupisce di nulla, che non s’indigna di nulla (sintomatica la scelta di Paolo di allestire una mostra riprendendo le carte geografiche dell’Africa colonizzata dagli inglesi). Zeichen fa “prosa civile” attraverso la rappresentazione di una irritante e sorniona città abitata da personaggi inutili nullafacenti, che frequentano ristoranti, gallerie d’arte, studi d’artista, musei, parlandosi addosso, fingendo amicizie ed amori evanescenti, scontrandosi su idee opposte ma senza mai troppa convinzione e troppo autentico impegno.
Ma Zeichen non risparmia neppure i presunti artisti che popolano i circoli e le gallerie: “mitomania, vittimismo, vanagloria, lati della personalità che avvolti in opportuna confezione potevano essere scambiati da talune ingenue per sintomi di genialità”. Come dicevo solo l’amore, anch’esso per molti versi superficiale, ma profondamente fisico e sensuale, talvolta dà un senso alla vita (e all’arte) in questo romanzo dai tratti settecenteschi, costruito su un gioco delle parti, allusioni e scambi di personaggi e caratteri. Tanto che mi sono immaginato che, data la evidente fonte autobiografica, i tre protagonisti siano aspetti della personalità dello stesso Zeichen.
Il romanzo non ha una volontà d’intrattenimento, ma è una sfida alla lettura, un impegno per i lettori : tale è la ricerca di Zeichen di “stare nella Lingua” abolendo ogni “falsetto estetizzante, disumano, pigramente discorsivo” come direbbe Giorgio Ficara (cfr. Lettere non italiane, Bompiani, 2016). L’umanità di Zeichen è reale, pur nel suo gioco estetico iperrealista, non c’è traccia di feticci mediatici e la luce grigia del racconto è la sola possibile per un’umanità disorientata e stanca. C’è un senso di solitudine e di tragica tristezza che solo la luce della Lingua riesce ad illuminare.
La prosa di Zeichen è ardua talvolta, ma sempre alta, con reminescenze moraviane, ma originale nella sua poematicità per nulla rarefatta e aerea, ma marcata e tagliente come un profilo sumero. Che sia un “gioiello da scoprire” non c’è dubbio, ma è un gioiello scuro, misterioso, indecifrabile. Siete avvisati.
Stefano Vitale