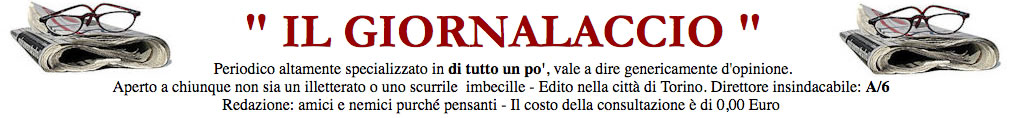Claudio Damiani
CIELI CELESTI
( Fazi Editore )
CIELI CELESTI
di
Claudio Damiani
“Cieli celesti” è il titolo di una breve raccolta di sedici poesie pubblicate nel 1982 in “Prato pagano” (editore Il Melograno) e scritte da Beppe Salvia, poeta scomparso troppo prematuramente. In quell’”Almanacco di prosa e poesia” c’era anche Claudio Damiani e c’erano anche Valerio Magrelli, Gabriella Sica (che aveva inventato la rivista), Vivian Lamarque. A parte quest’ultima, gli altri erano nati dopo il 1950, Damiani e Magrelli (entrambi del 1957) erano i più giovani. Tutti legati alla città di Roma ed alle esperienze di riviste come “Braci” che in quegli anni rappresentavano un polo di espressione molto significativa.
Questa nuova raccolta di Claudio Damiani non è quindi dedicata a caso proprio a Beppe Salvia, che di quel gruppo era forse il più originale, raffinato e carismatico. Ma non si tratta qui di un “ritorno alle origini” quanto di un esito, sicuramente alto e coerente, di un lungo percorso poetico. Leggendo questo libro mi è venuto in mente un frammento di Nietzsche presente in “Aurora”: “dobbiamo nuovamente cancellare dal mondo la molta, falsa grandiosità, perché essa è contro la giustizia alla quale hanno diritto tutte le cose dinanzi a noi. E per questo occorre che non si voglia vedere il mondo più disarmonico di quel che è” (pag. 13 edizione Mondadori, 1971). La poesia di Damiani credo voglia appunto dirci che ci dobbiamo dedicare a combattere la retorica di una poesia troppo astratta, astrusa, autoreferenziale e rendere giustizia alle cose reali della vita senza sottrarsi ad una visione armonica del mondo. Ma, attenzione, non si tratta di nascondere le inquietudini e gli interrogativi percorrono e attraversano senza sosta questa poesia costruita pure con un linguaggio chiaro, con lucido sture, esattezza appassionata e commossa.
Sin dai primi versi, Damiani propone il tema del rapporto problematico, poeticamente solido, tra esistenza individuale e mistero dell’universo. Il pensiero corre a Leopardi: “come siete lontani stelle e pianeti/dell’universo, quando potremo mai incontrarci,/come creature vive e intelligenti, uomini/come noi, sparsi come siamo tutti/ in uno sazio tanto grande?”. L’enjambement aumenta il senso del ritmo e del respiro concitato di un pensiero interrogante sospeso tra la trasfigurazione lenta, ma costante di tutte le cose e la distanza di spazi insondabili.
Ma già nella seconda poesia cogliamo il desiderio di un nesso: il Monte Soratte (che tornerà in altre poesie successive), così reale e vivo, diventa metafora di un legame tra l’uomo e la natura perché “ogni giorno perdiamo qualcosa, tutti e due/ma stiamo qui, non ci muoviamo,/…due oziosi difficili da scalzare”. Così lo stupore dinnanzi alla bellezza naturale, semplice e immediata, del mondo, del cielo azzurro, di un prato verde, della luna “partorita dalla stelle,/forse una costola della terra” diventa una forma di razionalità che ci salva dagli eccessi disarmonici, che ci introduce ad una calma riflessione sulla nostra stessa natura.
Damiani usa, come detto, un linguaggio diretto, discorsivo che in alcuni passi entra nella dimensione narrativa. Lo fa muovendosi con uno stile filosofico che ricorda il Leopardi delle “Operette Morali”: “pensiamo sempre che la materia venga prima della vita, e se fosse il contrario?” dove tuttavia lo scetticismo pessimistico è certo più temperato dal desiderio di abbandonarsi alla bellezza del mondo “bell’e fatto” (che mi ha fatto pensare a certi versi di Mariangela Gualteri).
Ma è il rovello del tempo a impedire questo totale abbandono. Perché c’è un continuo scambio di ruoli tra noi e il tempo, un intrinseco e crudele inseguimento (si veda la bella “Provo a immaginare che il tempo” a pag. 20) in cui ogni istante che passa è come “una mitragliatrice”. Ma, di nuovo, in una dialettica infinita, occorre sorprendersi di fronte alla normale eccezionalità del vivere, al semplice respiro che ci permette di restare seduti “senza pensare a niente”.
L’approccio di Damiani ha dei profondi legami con la classicità, quella poetica dei grandi elegiaci che lui ha studiato e tradotto: Tibullo, Properzio, soprattutto. Ma ha un riferimento anche nella poesia cinese del periodo della dinastia T’ang (618-906 d.C.) che lo ha ispirato per il suo precedente “Sognando Li Po” (Marietti, 2008). “Ho visto nella poesia cinese una poesia della terra, perfettamente oggettiva, sena il bisogno di nessuna metafora. Grande poesia della terra, della sua calma, della sua gloria” (ibidem, pag. 7). In quella raccolta troviamo versi quali “Cara sera, ascolto i tuoi pensieri/m’addormento con le tue note” (pag. 56) e ancora: “Riverso sulla barca guardo nuvole alte, /abbandonate sono le nuvole, abbandonato sono io,”… e poi “Guardo le stelle, sono elementi,/sono tante, non puoi controllarle tutte,” (pag. 57); e oltre “Nel piccolo giardino mi siedo un momento./Tempo, scorri pure.”.(pag. 61).
Allora, come in questa nuova raccolta, dietro l’apparente semplicità del verso si cela la sorpresa che nasce dall’improvvisa attenzione, dallo stupore per un dettaglio, spiazzante proprio perché evidente, dalla continua scoperta del rinnovarsi della vita e della natura, dell’essere-nella-vita . “Ma è questo, è proprio questo?/ Sì, è questo, è proprio questo” si legge a pag. 24 di “Cieli celesti” ricordando così l’atteggiamento di una poetessa come Wislawa Szymborska. Ma questo stupore, in Damiani, non è prodotto da uno scarto, da un sussulto, bensì da una paziente attesa, quasi scientifica: “sono qui, davanti a questa finestra, /e non me ne vado./ Sai quegli scienziati caparbi/ che ripetono all’infinito l’esperimento/ con una pazienza disumana?”. E’ questa una poesia del senso della vista, della calviniana capacità di osservare che non ha paura di usare anche termini che possono sembrare stereotipati (“vedo il cielo azzurro/a un tratto vedo alcune rondini,/sono arrivate, è primavera.”) perche forse quel che il poeta cerca è una sorta di poesia primigenia, originaria, classica, in cui gli arcaismi dell’infanzia entrino senza bussare. Così egli “prende il sole come un albero/nel mio piccolo spazio, il mio terrazzo” (26), da questo angolo di mondo che un punto di vista privilegiato non perché specialmente poetico, ma perché minimo, nascosto, lontano dagli sguardi altrui, immerso nella sobria necessità di una parentesi.
Ma il poeta non è solo, non è il depositario di una verità. Egli fa parte di una comunità dove esprimere il senso etico dell’appartenenza ad un comune relativo destino. Nella seconda sezione, Damiani assume un tono più educativo, esprimendo concetti, insegnamenti saggi e filosoficamente attenti. Damiani è antinichilista e tratta i temi della vita e della morte, della natura e della storia in una sorta di poemetto unitario. Qui usa anche un linguaggio decisamente parlato (“Ma che palle stare sempre lì/tutta la vita!”… in un’altra l’incipit è “Senti bella mia/non so cosa succederà/ quello che sarà di noi”), ma l’obiettivo è sempre quello di cogliere un dasein naturale dell’essere qui ed ora alleggerito dalla retorica dell’inquietudine troppo marcata, che non evita l’interrogare esistenziale ma che cerca consolazione nel “lasciati andare/la corrente ci porta a riva” (42), nella felicità di “essere uniti, /di esser l’uno all’altro indispensabili” (43) e nel “lascia correre il tempo dentro di sé/e si apre l’infinito” (44).
L’accettazione delle grandi leggi della vita: questo mi pare l’orizzonte filosofico in cui s’innesta la lirica di questo ultimo Damiani. Perché dobbiamo imparare a “cadere in piedi” (49), ad essere generosi come il sole (pag, 51), ad essere semplici ascoltando le voci dentro, anche quelle più apparentemente infantili (“Caro Sole, vorrei acchiapparti e baciarti” – pag. 52) e così capiremo che siamo irripetibili e “avere invidia per la nostra vita unica” – pag. 70), così scopriremo che, in uno slancio neo-francescano, “la gioia è in questo stare insieme/e accontentarsi di poco” (74).
La sezione “Dove siete tutti?” si apre con la poesia “Natale” che è emblematica della concezione poetico-filosofica di Damiani: il senso del transitare delle cose pur nel loro rimanere identiche a se stesse, il valore del dialogo transgenerazionale, l’attenzione per gli affetti familiari, la cura nel coltivare il futuro, piccolo o grande che sia. E molto indicativa mi pare anche la poesia “Aver vissuto” (pag. 97) che si svolge come una specie di inno all’unitarietà dell’universo e delle vite, quali che siano, come antidoto alla dispersione della contemporaneità conflittuale. La “palla di Parmenide” che tiene le vite del mondo tutte attaccate è una immagine filosofica chiara in questo senso. Così come è chiaro un saldo filo tra il bacio dato in cambio di una poesia (pag. 100) che scatena il “sentire il tuo respiro leggero/come un rumore di fondo” e l’“ascoltare il rumore di fondo/del big-bang dell’universo/ e ascoltare tutte le voci… di tutti i tempi come un sfrigolio” (101) in uno scambio di immagini e vibrazioni sommesse che generano il mondo e che da esso sono a loro volta generate.
Ma d’improvviso, nel mezzo della sezione “Schiavi di Dio” riemerge il dubbio e il desiderio di fermare tutto questo movimento universale e Damiani lo fa con ironia, come a voler smentire tutto: “Siccome è indubbio/che noi, dentro la natura,/abbiamo una missione… io, a volte, invidio quei vecchi/ che stanno tutto il giorno su una panchina/senza fare niente,/ e sprecano il loro tempo, lo lasciano passare/stando a guardare. “(107). Così si torna al tono dell’apertura della raccolta, un tono segnato da uno sguardo sorpreso, ma dubbioso, consapevole dei nostri limiti. E per questo è in cerca di uno straniamento che emerge dalla normalità. “Il mio è un punto d’osservazione/ma non si vede niente” (124) e ancora, ricordando Giorgio Caproni “c’è qualcosa che sfugge, /qualcosa che non tanto acchiappo io/ma lei, forse, acchiappa me” (124).
Meglio allora lasciare “passare il tempo”. In questa postura c’è il complemento poetico, il controcanto alla riflessione filosofica che Damiani cerca nella relazione di tutto con tutto (pag. 120). Siamo i “kamikaze, i viventi, /dalla nascita ci schiantiamo ogni giorno/sulle navi nemiche” (121), passiamo le notti “a piangere guardando il mare” (122); siamo “di quelli che non restano” (123) e perciò ci consoliamo con la filosofia che insegna che il nostro nascere e morire è il modo “per la natura, di evolvere”(126).
Ma il poeta non può evitare di dire “che avventure sono gli istanti”(142) e che, in uno slancio aforismatico “Noi pochi stiamo in prima linea/e della battaglia non capiamo niente.” (143). E’ un’altalena di contrasti fino a quando (pag. 146) si impone l’inutilità delle domande sul senso della vita perché conta il cerchio sicuro della vita concreta, della vita in quanto azione vissuta. E allora “godiamoci la gita, il paesaggio sul fiume” perché “siamo come turaccioli, foglie sul’acqua che scorre” (150) e dopo la vita c’è sempre ancora la vita. Si chiude il cerchio sul restare fermi a guardare le altre cose passare, il cielo, il tempo, gli istanti che hanno “una faccia che non ti saresti mai immaginato” (161) e al massimo possiamo camminare da soli, su un sentiero che non c’è più.
In “Cieli celesti” la poesia non nasce dall’uso più o meno ricercato di un lessico “poetichese”, né dalla esaperazione metaforica. Qui il paesaggio è sempre chiaro, preciso, naturale. Ma come nei quadri di Hopper dietro l’apparente normalità si cela qualcosa “d’altro”. Diventa così “poetica” la spinta lirica di una poesia che non cerca “lirismi” comodi e retorici; qui è “poetica” la parola che evade dal giardino incantato della poesia criptica per liberarsi nella vita così com’è; è “poetica” la consolazione classicista che ricompone gli strappi, le lacerazioni lasciando aperte le domande essenziali di sempre in un gioco dialettico-esistenziale che ci scuote nel mentre che ci accarezza.
Stefano Vitale