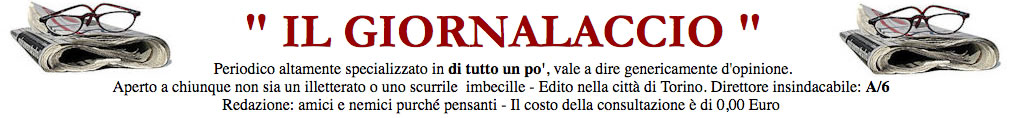Berlino si è trasformata
Un italiano direbbe, con il principe di Salina, che lo ha fatto per poter restare com’era. Già, ma com’era, se incessantemente si trasforma? Berlino non è l’orso nero del suo stemma – lo stemma è l’idea di come vorrebbe sembrare in quel suo eterno specchiarsi nel mastodontico enigma russo – come Carl Schmitt in Ex captivitate salus ricorda, facendo tesoro dell’intuizione di Kleist. Non sarà, invece, l’anziano fauno, sempre in procinto di scivolare in balìa delle ninfe dell’acqua, che tuttavia non disdegna – come appare dall’immagine in pietra posta all’ingresso della Hochschule der Kuenste, l’Accademia di Belle Arti – ma non può neppure far torto alle Naiadi delle foreste, che lo attirano dalla parte della terra. Berlino si ripartisce equamente: un terzo a se stessa, all’umano, un terzo ai boschi e un terzo alle acque. Ecco perché si trasforma: perché, in fondo, non esiste come città, essendo un insieme di villaggi o cittadine, ciascuna con un suo centro e un suo municipio, tenute insieme da non altro che da una ‘rete’ di sotto e di soprastrade, che ne agevolano l’osmosi preservandone l’identità.
Queste identità possiedono l’incantevole pregio di non esporsi: non amano farlo, né, tanto meno, proclamarsi rischiando, come pare il destino di ogni luogo di rendersi facile bersaglio d’ironia. Iniziate da secoli al gesto ironico, sanno come nascondersi e amano farlo. Ora, ad esempio, stanno egregiamente dando prova di quest’arte nascondendosi dietro l’idea di un centro – Potsdamer Platz – a cui tutte dovranno ricorrere per riconoscersi. Ma questo centro non è che una trappola di specchi dove i volti di Berlino passano senza lasciare tracce: non ne hanno bisogno, sono quelli delle ninfe delle onde e delle foglie. E’ da loro che la piazza ha tratto recondita ispirazione, con i suoi cristalli, con i suoi cementi legnosi, con gli specchi d’acqua che annullano la spinta verso l’alto per la compensazione della riflessione. Eppure, le forze esogene della natura dovrebbero essere finalmente imbrigliate, per dare a quella che vuol farsi chiamare città un centro dove saranno solo le ancelle di un re illuminato.
Da qui si godrà dell’immagine della globalizzazione: l’estetica la riscatterà arrogandosene il senso, come il racconto filosofico di Sloterdyik legge nell’alveo materno e nello sfero parmenideo il codice genetico dell’era globale. Prigionieri di una forma biologica che dall’ordine dell’essere all’ordine del nascere plasma ogni cosa, in un senso incontrovertibile, perché anzitutto presente, e poi vario e multiforme, ci stupiremmo di non ricorrere ad un centro, ora che ci muoviamo da un punto all’altro, incessantemente.
Prima, quando il feto se ne stava tranquillo e invisibile, ancora in incognito nella sua placida privacy, le cupole si costruivano in mattone e cemento, ora, che l’occhio è riuscito ad insinuarsi nel grembo del possibile – per controllarne i movimenti e guidarlo con le briglie della necessità – si costruiscono col vetro: la semisfera trasparente incastonata nel Reichstag. Non ci saranno sorprese, tranquilli: il potere si svilupperà secondo ragione e necessità storica e non nutrirà in grembi oscuri di sorta mostruosità nefande, ma il potere è globale: non ne avrebbe, a ben guardare, bisogno. Gli specchi delle ninfe dell’acqua, le ombre delle ninfe delle foglie passano attraverso le forme dello sfero facendone sparire a tratti la compattezza, facendosi gioco, a tratti, della sua perfezione. Chissà perché avviene questo, sotto gli occhi divertiti del vecchio fauno. Forse perché loro, naiadi e ninfe, non furono propriamente concepite nella sostanza tipicamente umana, anche se umana, preferibilmente, è la loro forma: nulla hanno a che fare con lo sfero globale, che le contiene e le trattiene ma senza riuscire davvero a sottometterne la misteriosa, non umana energia.
D’altra parte, anche il vecchio fauno, com’era detto all’inizio, ama nascondersi e soltanto la gaia potenza del suo entourage glielo concede.
Monica Ferrando
Ottobre 2007